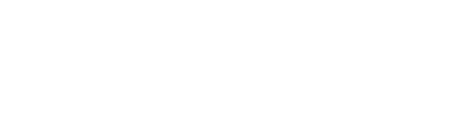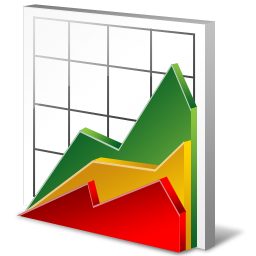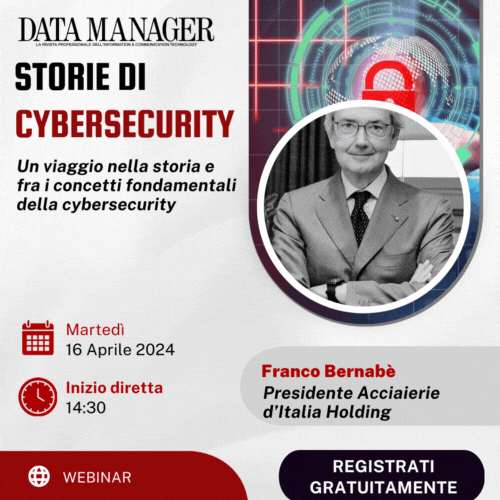Dalla sperimentazione all’industrializzazione: i quattro pilastri per il successo dei progetti AI
Nonostante l’afflusso di capitali, che si stima tra i 30 e i 40 miliardi di dollari, l’investimento nelle tecnologie di intelligenza artificiale generativa, o GenAI, non sta producendo i risultati sperati. Un dato che emerge dal rapporto “State of AI in Business 2025” del Mit: il 95% dei progetti lanciati dalle aziende non riesce a generare un impatto concreto e misurabile sul loro bilancio. La ricerca, basata sull’analisi di oltre 300 iniziative di intelligenza artificiale e su un’ampia raccolta di dati da interviste e questionari, ha messo in luce una profonda frattura, che è stata definita il “GenAI Divide”.
Questo divario separa un piccolissimo gruppo di successi dall’enorme massa di insuccessi. Soltanto un esiguo 5% dei progetti pilota, infatti, è riuscito a superare la fase iniziale e a integrarsi con successo nei processi aziendali, generando ritorni economici significativi. Al contrario, la maggior parte delle iniziative rimane in una fase di stallo, incapace di tradurre il potenziale tecnologico in valore reale. Da cosa dipende? Non tanto dalla qualità dei modelli di intelligenza artificiale o nella complessità delle normative ma dall’approccio che le aziende adottano. Il fallimento di tanti progetti non è un limite della tecnologia in sé ma una conseguenza di una strategia d’implementazione inadeguata.
“Servono competenze cross, che non possiamo più definire solo tecnologiche o strategiche” ci dice Marco Appetito, Digital Innovation & Architetture Applicative Competence Center Director di Aubay. “In tal senso, diventa centrale il ruolo della consulenza, che può unirsi a quello della tecnologia per creare valore”. Quello che oggi vediamo è una proliferazione di soluzioni tecnicamente eleganti ma strategicamente poco utili, sviluppate senza un legame chiaro con obiettivi misurabili. Questa inversione di priorità condanna i progetti fin dalla loro concezione, trasformando l’IA in un esercizio accademico piuttosto che in uno strumento di crescita.
La questione dei dati rappresenta un altro tassello fondamentale. Gli algoritmi di machine learning dipendono dalla qualità delle informazioni su cui vengono addestrati, eppure molte aziende sottovalutano sistematicamente l’importanza di una data governance solida. “Dataset incompleti, inconsistenti o di scarsa qualità diventano la base fragile su cui costruire modelli predittivi destinati al fallimento. In numerosi casi si scopre troppo tardi che l’organizzazione non dispone delle infrastrutture necessarie per raccogliere, pulire e gestire le informazioni in modo efficace”.
Il problema dell’isolamento e della scalabilità
Un elemento ricorrente nei fallimenti dell’IA è la tendenza a confinare i progetti in laboratori di innovazione o piccoli team specializzati, senza mai integrarli nei processi operativi dell’azienda. “Questi proof of concept rimangono isolati dal resto dell’organizzazione” continua Appetito “incapaci di scalare e di generare impatti trasversali. L’entusiasmo iniziale si scontra con la difficoltà di tradurre i risultati sperimentali in soluzioni operative, creando frustrazione e perdita di credibilità interna”.
La frammentazione delle competenze aggrava ulteriormente il problema. L’implementazione efficace dell’IA richiede team ibridi che combinino expertise tecnica, conoscenza del dominio applicativo e capacità manageriali. “Troppo spesso questi elementi rimangono separati, impedendo quella contaminazione di saperi necessaria per tradurre le potenzialità tecnologiche in risultati concreti. Data scientist brillanti lavorano in isolamento rispetto agli esperti di business, mentre i manager faticano a comprendere le implicazioni operative dei modelli sviluppati”.
L’assenza di una struttura di governance completa definisce il quadro delle criticità. “Senza KPI chiari, senza sponsor interni forti, senza un modello di monitoraggio continuo, diventa impossibile misurare davvero il valore generato. I progetti rimangono senza una direzione precisa, perdendo credibilità all’interno delle stesse aziende che li hanno avviati”.
Verso un nuovo paradigma di implementazione
Per Appetito, la trasformazione richiede dunque un ripensamento radicale dell’approccio all’IA, basato su quattro pilastri fondamentali che possono invertire la tendenza al fallimento. Il primo elemento riguarda l’allineamento strategico: ogni progetto deve nascere da una chiara comprensione del valore che può generare per il business. “L’IA deve servire la strategia aziendale, non rappresentare un esperimento tecnologico fine a sé stesso. Questo significa identificare use case concreti e misurabili, capaci di impattare tanto sull’efficienza interna quanto sull’esperienza del cliente”.
Le architetture digitali scalabili costituiscono il secondo pilastro di questo nuovo approccio. I progetti devono essere concepiti fin dall’inizio con una visione sistemica, progettati per crescere insieme al business e integrarsi con i sistemi esistenti. “Solo superando i limiti dei prototipi isolati è possibile costruire vere piattaforme di innovazione che generino valore duraturo nel tempo”.
“Il terzo elemento fondamentale riguarda la costruzione di infrastrutture dati robuste e affidabili. Investire in processi di raccolta, pulizia e gestione delle informazioni significa creare le fondamenta per modelli accurati e decisioni affidabili”. Senza questa base solida, anche i progetti più ambiziosi sono destinati a fallire indipendentemente dalla sofisticatezza degli algoritmi utilizzati.
“Infine, la centralità delle persone rappresenta il quarto pilastro di questa trasformazione. L’IA deve essere progettata per supportare i decisori umani, non per sostituirli. Questo implica promuovere un cambiamento culturale che accompagni quello tecnologico, favorendo l’accettazione e l’adozione degli strumenti da parte di chi dovrà utilizzarli quotidianamente”. Attraverso questo approccio antropocentrico è possibile trasformare la resistenza in collaborazione.
“In Aubay, la creazione di Centri di Competenza dedicati è una conseguenza diretta di queste sfide” conclude il manager. “Questi centri si occupano di tradurre il linguaggio della tecnologia in valore aziendale, creando percorsi che riducono i rischi e aumentano le possibilità di successo. Non si tratta di proporre soluzioni standardizzate, ma di lavorare in stretta sinergia con le organizzazioni per creare architetture resilienti e flessibili, in grado di evolversi con l’evoluzione delle esigenze aziendali”.
L’integrazione tra competenze tecnologiche e conoscenza settoriale diventa così il catalizzatore per team ibridi in grado di coniugare innovazione e pragmatismo. “Come consulenti, crediamo che il nostro ruolo sia guidare le imprese in questo percorso. Non si tratta di correre dietro all’ultima tecnologia, ma di costruire strategie solide, di integrare soluzioni nei processi, di generare risultati tangibili e misurabili. Il passaggio necessario è quello da progetti sperimentali a strategie strutturate, da iniziative isolate a modelli integrati e sostenibili”.