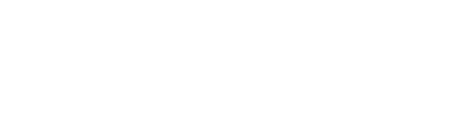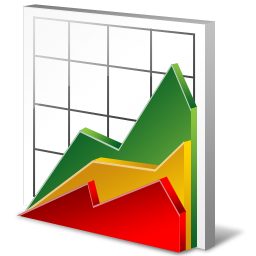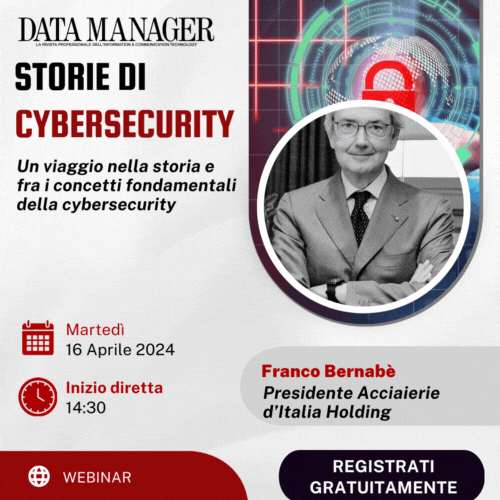A cura di Gianluca Sinibaldi, Direttore Energy & Utilities, Minsait in Italia (Indra Group)
Nel pieno della trasformazione che sta investendo l’economia globale, la protezione delle infrastrutture critiche energetiche è passata da funzione specialistica a condizione abilitante della sicurezza nazionale e della continuità dei servizi essenziali. La progressiva digitalizzazione dei processi, e la conseguente esposizione a minacce ibride e ad alto impatto, impone un cambio di paradigma: superare la tradizionale separazione tra sicurezza fisica e cybersecurity e adottare un approccio realmente convergente, capace di integrare domini fisici, IT e OT. Gli eventi degli ultimi anni, come attacchi informatici su scala, guerre ibride, sabotaggi a impianti energetici, collassi di rete, calamità naturali e pandemie, hanno dimostrato che servono sistemi interoperabili, rapidi nel decision-making e non più vincolati a schemi di risposta lineari.
Per farvi fronte, l’Unione Europea sta adottando diverse misure: il Fondo Europeo di Difesa per sostenere ricerca e sviluppo di tecnologie innovative, lo Scudo europeo di Cybersecurity con una rete di Centri Operativi coordinati, le direttive NIS 1 e NIS 2 per rafforzare la sicurezza informatica, e la direttiva CER per estendere la resilienza delle infrastrutture critiche a più settori. Inoltre, la European Defence Industrial Strategy mira a potenziare l’industria della difesa, prevedendo nuovi finanziamenti e imponendo agli Stati membri di destinare una quota significativa del loro bilancio al settore.
In questo contesto il mercato della protezione delle infrastrutture critiche sta registrando una crescita esponenziale: secondo il report “Critical Infrastructure Protection Market” pubblicato da MarketsandMarkets, raggiungerà i 197,13 miliardi di dollari entro il 2030. Questo segmento rappresenterà la quota di mercato più ampia del mercato globale della protezione delle infrastrutture critiche nel periodo 2025–2030, grazie alla crescente necessità di proteggere impianti, personale e asset di diverso genere da minacce fisiche come furti, sabotaggi e terrorismo. Il Medio Oriente e l’Africa, nell’immediato, registrano il tasso di crescita più elevato, visti i numerosi investimenti già avviati, in energia, trasporti, infrastrutture urbane e progetti smart city.
La tecnologia rappresenta certamente il motore, ma ciò che fa davvero la differenza è la capacità di costruire un modello integrato di prevenzione e risposta. Le nuove soluzioni devono andare oltre la semplice somma di strumenti: occorre creare un sistema che raccolga e interpreti in tempo reale informazioni provenienti da fonti diverse, che sappia trasformare i dati in decisioni operative immediate e che permetta di coordinare attori diversi con la massima tempestività. Fondamentale è anche la possibilità di simulare in anticipo scenari di crisi, così da testare strategie e verificare l’efficacia delle azioni prima che un evento si verifichi realmente. Solo piattaforme aperte e modulari, pensate per dialogare con i sistemi già in uso, possono garantire questa agilità, trasformando la tecnologia in un alleato concreto della resilienza energetica.
In pratica, la protezione delle infrastrutture energetiche deve poggiare su una regia unica, capace di integrare sicurezza fisica e digitale. Parliamo di strumenti che spaziano dalla videosorveglianza avanzata ai sistemi di controllo degli accessi, da reti di comunicazione di emergenza a centri di comando che restituiscano una visione complessiva e condivisa della situazione. A questi si affiancano soluzioni più innovative, come l’impiego di droni, l’analisi dei flussi in tempo reale e l’intelligenza artificiale, utili a ridurre i tempi di reazione e a rafforzare la prevenzione. Ciò che conta, tuttavia, è l’architettura di insieme: un sistema aperto, capace di crescere nel tempo e di adattarsi a minacce che cambiano di continuo, senza disperdere gli investimenti già effettuati.
La tutela delle infrastrutture critiche è ormai un asset strategico delle politiche industriali e della sicurezza europee. Normativa (come NIS2 e CER), incentivi e innovazione tecnologica spingono oltre la prevenzione: verso sistemi capaci di anticipare, assorbire e recuperare. In questa traiettoria, il valore risiede nella possibilità di misurare gli esiti concreti — riduzione del rischio operativo e reputazionale, contenimento dei tempi di fermo, conformità by design — e nella capacità di scalare nel tempo: partire dall’integrazione dell’esistente, crescere per moduli, mantenere il controllo dei dati e delle interfacce. È così che la resilienza si afferma come un vantaggio competitivo, oltre che come presidio essenziale di stabilità per la società.