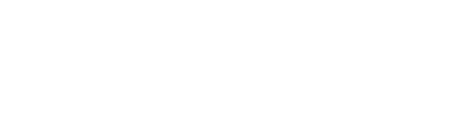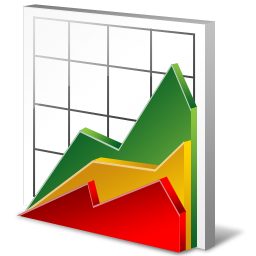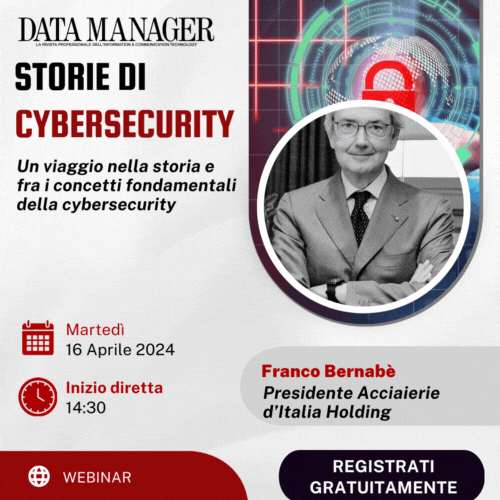A cura di Giacomo Parravicini, CEO di Minsait Cyber in Italia
La trasformazione digitale dell’industria degli ultimi anni ha oltrepassato una soglia invisibile. I sistemi di controllo, le reti produttive, le fabbriche, i trasporti e, in generale, tutte le infrastrutture critiche, non vivono più in un perimetro isolato: sono diventati nodi di un’infrastruttura connessa, dinamica, in cui la componente IT (Information Technology) e quella OT (Operational Technology) si intrecciano fino a convergere. È un salto che ha moltiplicato l’efficienza, ma anche la superficie d’attacco. La cybersecurity OT è il nuovo terreno su cui si misura la continuità industriale di un Paese.
Gli incidenti che colpiscono i sistemi industriali non sono più eccezioni, ma sintomi di una vulnerabilità sistemica. Secondo il rapporto Clusit 2025, i cyber attacchi che hanno colpito esclusivamente la componente operativa sono cresciute in modo significativo, passando dal 17% al 24% in un solo anno. Parliamo di attacchi capaci di bloccare catene produttive, rallentare reti di distribuzione o compromettere infrastrutture critiche, con impatti che si estendono ben oltre l’ambito digitale e mettono alla prova la stessa continuità industriale di interi settori.
In questo contesto, una strategia di protezione efficace poggia su tre pilastri essenziali: la continuità operativa, la protezione della supply chain e la governance. Tre dimensioni che si intrecciano e si rafforzano a vicenda, trasformando la sicurezza da funzione difensiva a leva di competitività industriale.
Continuità operativa
Proteggere la tecnologia operativa significa prima di tutto preservare la capacità di funzionare, di garantire servizi essenziali anche sotto pressione. La sicurezza, in questo contesto, non è più un costo di conformità, ma un fattore produttivo: serve a evitare interruzioni, a ridurre i tempi di fermo, a mantenere intatti i flussi di valore. L’attenzione si sposta quindi dal dato, al processo, dall’integrità informatica, alla resilienza industriale. Ma la continuità non si costruisce solo con le tecnologie: nasce dalla capacità di leggere i processi, di individuare le dipendenze critiche, di pianificare interventi che non compromettano la stabilità operativa.
Protezione della supply chain
Questa consapevolezza si estende ben oltre i confini dell’impianto: l’ecosistema industriale contemporaneo è una rete fitta di fornitori, manutentori, partner e operatori remoti, una filiera connessa in cui la vulnerabilità di uno può diventare la vulnerabilità di tutti. È necessario adottare controlli comuni, condividere policy di accesso, formare le persone che operano lungo la catena del valore. La sicurezza, in questo senso, non è una barriera, ma una forma di collaborazione: un contratto di fiducia che attraversa l’intero ecosistema produttivo.
Governance
Questo è l’elemento che tiene insieme tutti gli altri. Senza una regia chiara, la sicurezza resta frammentata: una somma di soluzioni che non fa sistema. Le organizzazioni che raggiungono la maturità in ambito OT sono quelle che trattano la sicurezza come un processo di gestione, con ruoli definiti, metriche, revisioni periodiche e un allineamento costante agli standard internazionali. Tra questi, la norma IEC 62443 è oggi il riferimento più solido: fornisce una cornice per segmentare le reti, definire i livelli di privilegio, gestire l’intero ciclo di vita della sicurezza. Non è un esercizio formale: è il modo per trasformare le buone pratiche in vantaggio competitivo, rendendo la protezione parte della qualità complessiva del sistema industriale.
Alla fine, la sicurezza OT è un linguaggio che obbliga mondi diversi a parlarsi. Ogni ruolo — ingegneri di impianto, esperti IT, manager della produzione e analisti di rischio — ha le proprie responsabilità, ma tutti condividono l’obiettivo della protezione OT. Non si tratta di moltiplicare le regole, ma di creare una cultura in cui la protezione è condizione di sviluppo, la prevenzione è parte del valore e la resilienza è una misura della leadership.