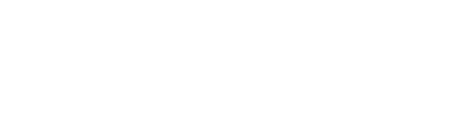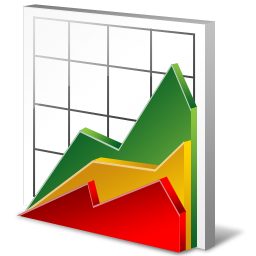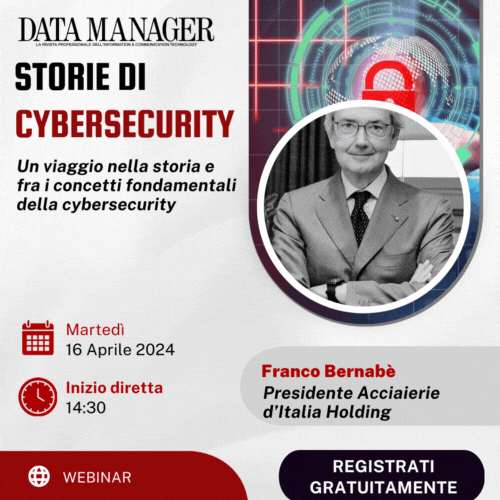Quando le aziende investono nell’IA, la prima domanda è spesso: qual è il ritorno sull’investimento? Ecco il framework vincente per SAS
Le aziende continuano a interrogarsi sul ritorno economico degli investimenti in intelligenza artificiale applicando modelli di calcolo obsoleti, simili a quelli utilizzati per l’acquisto di un server o l’implementazione di un sistema CRM. Questo approccio, però, rischia di trasformarsi in un errore strategico capace di frenare l’innovazione e limitare la comprensione delle reali potenzialità di questa tecnologia.
L’intelligenza artificiale non rappresenta infatti un semplice strumento da aggiungere all’infrastruttura esistente, ma una trasformazione radicale nel modo di pensare, decidere e operare all’interno delle organizzazioni. C’è un parallelo con l’alba di internet: agli inizi dei 2000 nessuno era in grado di fornire calcoli precisi sul ritorno economico di un sito web aziendale. Col in senno di poi, chi non ha costruito una presenza digitale si è ritrovato condannato all’irrilevanza. Secondo Marinela Profi, Global AI & Generative AI Market Strategy Lead di SAS, oggi ci troviamo di fronte a un bivio simile, dove tentare di quantificare l’IA attraverso parametri tradizionali significa perdere di vista la portata del cambiamento in atto.
“I metodi classici di valutazione si concentrano esclusivamente su risultati misurabili nel breve periodo: riduzione dei costi operativi, risparmio di tempo e incremento della produttività. Questi indicatori, pur mantenendo la loro importanza, raccontano solo una frazione della storia quando applicati alle iniziative di intelligenza artificiale” dice Profi. Il rischio concreto consiste nel sottovalutare il potenziale strategico privilegiando l’efficienza rispetto all’innovazione, disincentivando così progetti ambiziosi capaci di generare trasformazioni durature.
Come misurare il cambiamento
Un caso emblematico è l’esperienza di SAS portato avanti con una banca dove l’intelligenza artificiale generativa non si è limitata ad accelerare i processi di acquisizione clienti. La tecnologia ha innescato una nuova dinamica collaborativa tra i team di conformità normativa, legale e front-office, “Questo impatto culturale non era incluso nel foglio di calcolo originale del ROI, ma ha creato un effetto a catena di innovazione. Ecco perché abbiamo bisogno di un framework migliore” dice.
Per superare una visione limitata serve adottare un modello concettuale a tre livelli che rifletta l’intera portata dell’impatto tecnologico. “Al livello base si colloca l’efficienza operativa, il punto di partenza per la maggior parte delle organizzazioni: automazione di attività ripetitive, ottimizzazione dei tempi e contenimento dei costi. Parliamo di report automatizzati, elaborazione accelerata di documenti e chatbot che gestiscono le richieste dei clienti. Elementi preziosi ma non trasformativi, come valutare la posta elettronica semplicemente contando quante lettere cartacee sostituisce”. Il livello intermedio, spesso trascurato, riguarda la qualità decisionale e rappresenta il punto dove inizia la vera differenziazione competitiva. “I sistemi di AI identificano pattern nascosti, rilevano anomalie e producono insight che conducono a decisioni più accurate nella valutazione del rischio creditizio, nel rilevamento delle frodi, nelle previsioni della supply chain e nella segmentazione della clientela”.
Questi miglioramenti potrebbero non manifestare un valore monetario immediato, ma si accumulano nel tempo riducendo i rischi e aumentando la precisione in ambiti critici. Al vertice della piramide si posizionano innovazione e cultura organizzativa, “l’aspetto più sfuggente ma anche il più potente” sottolinea il manager. Qui l’intelligenza artificiale diventa catalizzatore per la creazione di nuovi prodotti e servizi, per ripensare modelli di business consolidati e sviluppare una cultura aziendale orientata ai dati e alla sperimentazione. “Non conta solo ciò che l’IA realizza, ma ciò che rende possibile: le organizzazioni che abbracciano questa dimensione non si limitano a migliorare i processi esistenti, li reinventano completamente”.
Applicare esclusivamente la lente tradizionale del ritorno sull’investimento porta a privilegiare risultati immediati e facilmente raggiungibili, svalutando i benefici a lungo termine e compromettendo l’innovazione strategica. “Un framework a tre livelli riflette l’intera portata dell’impatto dell’IA e permette ai leader di giustificare investimenti più consistenti, definire metriche di successo realistiche e concentrarsi su trasformazioni sostenibili nel tempo”. Per SAS, la domanda da porsi non è quale sia il ritorno economico di un singolo modello di intelligenza artificiale, ma quali opportunità si aprono trasformandosi in un’impresa nativa IA. Significa costruire capacità di risposta rapida ai rischi, personalizzare profondamente le interazioni con i clienti, adattarsi agilmente alle normative e preparare i talenti alle prossime ondate di innovazione.
Per maggiori informazioni clicca qui