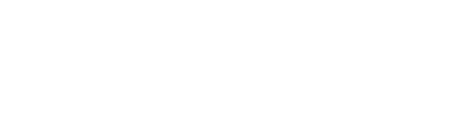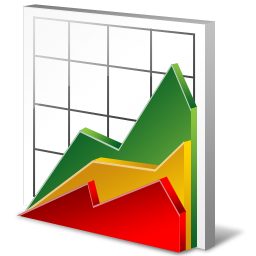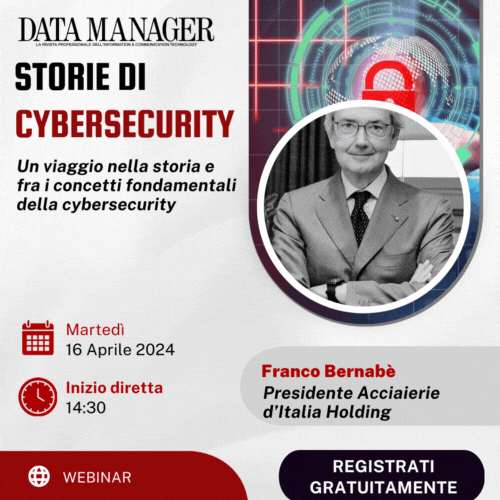La fragilità che diventa forza, il fallimento che apre la strada, l’amore che ritorna, il talento che si riconosce solo oltre l’apparenza. «L’innovazione è dialogo tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare»
Nel cinema di Pupi Avati – classe 1938, 54 film diretti, 53 sceneggiature scritte – dietro ogni “Cavaliere che tenta l’impresa” c’è sempre un “Ultimo minuto” di coraggio, un “Regalo di Natale” inaspettato, una “Storia di ragazzi e di ragazze” che si trasforma in ricordo, cultura e innovazione. Il suo sguardo è profondamente umano come in “Fratelli e sorelle”, “Il cuore altrove”, “Una sconfinata giovinezza”. Perché anche nel mondo più tecnologico, il progresso nasce dalle relazioni, dai sogni, dalle emozioni.
Come ogni organizzazione matura, anche il suo cinema diventa consapevolezza. Con “L’orto americano” e “Nel tepore del ballo” di prossima uscita, Avati ci ricorda che innovare significa anche coltivare, con pazienza e cura, un terreno inesplorato, ma mai il proprio “orticello”. Perché ogni percorso è sempre una storia di caduta e rinascita, che si intreccia con l’esistenza degli altri di cui facciamo parte, a volte come coprotagonisti, a volte come semplici comparse.
Pupi Avati non è solo un regista: è un artigiano dell’immaginario, un innovatore che trasforma le storie in ecosistemi di significato. Nel suo cinema, come nel business, l’evoluzione non è una linea retta, ma una narrazione ciclica, viva, fatta di rischio, di sogno e di invenzione continua.
«L’innovazione è dialogo tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare». Il linguaggio è il sistema operativo per leggere, pensare, raccontare e reinventare la realtà. La vita è la curva di un sentiero che si arrampica fino a scollinare. Il passato ci aspetta e si ricongiunge con il presente: luogo della memoria e delle radici. E da lì si ricomincia, per costruire qualcosa di nuovo e per rinnamorarsi della vita, come nella sua autobiografia dal titolo “Rinnamorarsi” (Solferino, 2025). E forse è proprio questo il senso più profondo dell’innovazione: non dimenticare chi siamo, mentre impariamo a diventare la versione migliore di noi stessi.
L’inizio della salita
A chiusura della decima edizione di WeChange IT Forum 2025, l’intervento di Pupi Avati non si può considerare un keynote né una lectio magistralis, ma una condivisione a bassa voce che ha il sapore di una conversazione tra vecchi amici. L’esordio di Pupi Avati alla regia inizia nel ‘68 con titoli controcorrente, che già annunciano il coraggio di entrare in territori inesplorati (“Balsamus, l’uomo di Satana”). Avati attraversa l’incertezza del cambiamento in “Thomas e gli indemoniati” (1970), per poi trasformare l’improbabile in arte come nella “Mazurka del barone, della santa e del fico fiorone” (1975): una sinfonia di elementi diversi che, insieme, generano qualcosa di nuovo. C’è la paura di sbagliare nella “Casa dalle finestre che ridono” (1976), ma anche la forza di reinventarsi in “Tutti defunti… tranne i morti” del 1976, perché solo chi accetta di “morire” può trasformarsi e trasformare la realtà. E poi arriva la fase visionaria: “Aiutami a sognare”, “Una gita scolastica”, “Noi tre”: tutti titoli che parlano di formazione, apprendimento, sperimentazione di senso.
Riconoscere il talento negli altri richiede a sua volta il talento di intuire la poesia segreta delle persone che incontriamo tutti i giorni. Nella vita professionale come nella vita: «Molti scelgono senza saper scegliere» – osserva Pupi Avati. È una constatazione amara: l’incompetenza non è ignoranza tecnica, ma mancanza di sensibilità umana. «E ogni essere umano – lo ricorda con tenerezza – porta con sé una storia irripetibile, un sogno che chiede solo di essere accolto, raccontato, fatto vivere».
L’incontro decisivo
Il regista ritorna alla Bologna degli anni Cinquanta, quando è ancora convinto che la musica sia il destino che lo attende. Suona il clarinetto, strumento che maneggia con discreta ambizione finché non incontra Lucio Dalla, che suona lo stesso strumento. «Ma clamorosamente meglio». Il jazz è competitivo – ricorda Avati. «Non si suona insieme, si suona uno contro l’altro». Quando capisce che quell’omino barbuto, inizialmente sottovalutato per l’aspetto esteriore, è un genio inarrestabile, arriva persino ad augurargli una brutta fine. Avati lo dice con quell’ironia tragica tipica dei suoi racconti. Davanti ai compagni della Doctor Dixie Jazz Band, annuncia il suo addio alla musica. «Nessuno si oppone» – nota con un sorriso che non tradisce alcuna amarezza. Fine di un sogno. Poi il ritorno alla realtà: un impiego stabile come dirigente in una fabbrica di surgelati. «I quattro anni più brutti della mia vita. Tanti sarebbero stati felicissimi alla Findus. Io no».
Il fallimento e la fuga a Roma
Il destino cambia direzione in una sala buia, grazie a “Otto e mezzo” di Federico Fellini. La visione di quel film lo fulmina. Scopre che il cinema ha la potenza di raccontare l’intimità, ciò che si nasconde sotto la pelle delle persone. Alla fase della scoperta, segue quella della produzione, con alcuni ragazzi di Bologna. Un’avventura, che lo stesso regista non esita a definire «disastrosa». Due film, un fallimento economico colossale e la fuga a Roma. Due anni bastano per convincerlo che è tempo di ricominciare da capo. E tuttavia, dice Avati: «I nuovi inizi non devono mai spaventare». Anzi, più un sogno è ambizioso, più ha possibilità di realizzarsi. «Il vero problema sono i sogni modesti».
Lo “scollinamento”
Nella sua autobiografia, Pupi Avati parla di un sentimento nuovo: la riemersione di voci, volti, odori dell’infanzia e di un’Italia ormai evaporata. Racconta della ragazza, diventata sua moglie, della corte ripetuta al limite dello stalking e del sì pronunciato più per sfinimento che per entusiasmo. Sessant’anni dopo, Pupi Avati si riscopre innamorato di lei come il primo giorno, ma con la limpidezza dello sguardo maturo. La vede come all’inizio: una delle ragazze più belle di Bologna, con quella fierezza misteriosa delle donne che non si lasciano mai domare del tutto. E riconosce che quella donna – con cui l’interlocuzione quotidiana si riduce a un “ciao” e un “ah!” – gli è diventata oggi ancora più attraente di ieri, non per eros ma per rivelazione: «È la stessa bellezza, tornata da lontanissimo».
Nell’età che avanza – sostiene Avati – accade qualcosa di sorprendente: «Si ritorna bambini». Nella cultura contadina la vita è come una collina: «Si sale con l’illusione di diventare qualcuno, si arriva in cima e ci si accorge che il percorso è più interessante della meta». È la Madeleine proustiana: lo sguardo che dal futuro si gira verso il passato, come se da quella vetta il mondo illuminasse all’indietro la strada dell’infanzia, donandole un significato nuovo. E qui Avati introduce un’altra immagine: la vita come un’elisse. Il bambino che scopre il mondo, il ragazzo che capisce la finitezza delle cose, l’adulto che crede di poter costruire tutto. Poi il vertice, e infine la discesa: «Lo scollinamento, che è anche una liberazione».
Il punto d’arrivo
Con l’autoironia che non gli fa difetto, Pupi Avati racconta il ritorno ai piccoli gesti e alle abitudini dell’infanzia – le caramelle come un bene di prima necessità – e accenna alle varie incontinenze della vecchiaia: quelle che non vale la pena nominare. E quelle che rendono anche i cinici incalliti più umani. La trasformazione radicale è un’altra: «Ridere e piangere per niente, liberi come bambini». È la vulnerabilità, che Avati definisce come il punto d’arrivo dell’essere umano, la condizione che rende finalmente capaci di riconoscere l’altro, soprattutto il debole, il timido, lo sconfitto. È in quella fragilità, non nell’assertività, che si ritrova la verità di sé. Il racconto di Pupi Avati si chiude con l’immagine di un piano sequenza: un portone, una scala, una porta che si apre su un corridoio, poi un’altra porta, una cucina. E dentro quella stanza, due esseri umani che lo aspettano per cena: suo padre e sua madre. È il ritorno all’origine, dove tutto comincia e tutto, misteriosamente, ritorna.