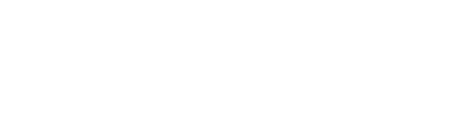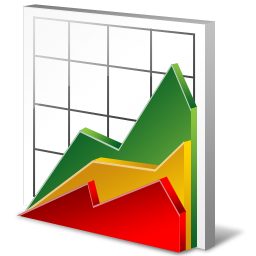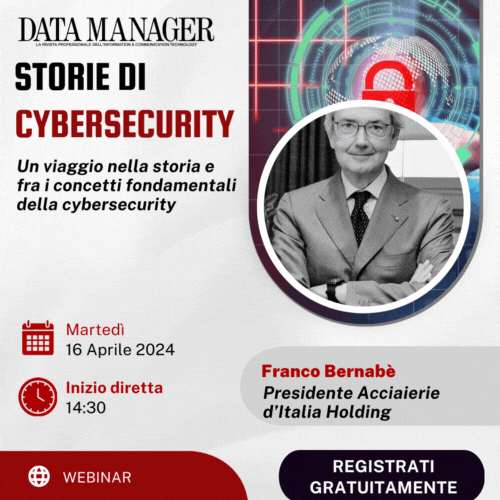Il 27% delle risorse del PNRR punta alla trasformazione della PA. Obiettivi per il 2026: identità digitale per il 70% dei cittadini, 75% delle amministrazioni centrali e locali in cloud, rete ultraveloce e 400 progetti pilota di intelligenza artificiale
La Pubblica Amministrazione è sempre sotto osservazione per quanto concerne la capacità di erogare servizi in grado di rispondere prontamente ai bisogni del cittadino, sfruttando il digitale come leva di ottimizzazione dei processi. Molto spesso la tecnologia è stata vista solo come uno strumento per digitalizzare, riducendo i processi alla semplice dematerializzazione, senza affrontare la vera sfida: trasformare profondamente l’intero funzionamento della Pubblica Amministrazione. Il ricorso all’automazione dei processi, alla condivisione dei dati e a tecnologie moderne e scalabili è l’unica via per ridurre i tempi di risposta e migliorare l’efficienza operativa. Le professionalità presenti nella Pubblica Amministrazione si stanno velocemente adeguando, ciò che ancora deve avvenire è un cambio di visione e una adozione a livello capillare su tutte le realtà territoriali e non solo centralmente. Oggi a livello tecnologico le soluzioni esistono e alcune amministrazioni hanno già intrapreso questo percorso trasformativo. Ora occorre continuità di intenti e visione di lungo periodo, oltre che investimenti adeguati: unica via per ottenere i benefici attesi.
ITALIA DIGITALE 2026
Analizzare lo stato dell’arte della trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione non può che partire da dati relativi agli investimenti. Secondo il piano di Italia Digitale 2026, il 27% delle risorse totali del PNRR sono dedicate alla transizione digitale. Il Piano strategico si sviluppa su due asset: da una parte le infrastrutture digitali e la connettività a banda ultra larga, dall’altra tutti quegli interventi volti a trasformare la PA in chiave digitale. Ancora più importante è l’affermazione che i due pilastri sono necessari per garantire che tutti i cittadini abbiano accesso a connessioni veloci per vivere appieno le opportunità che una vita digitale può e deve offrire, e per migliorare il rapporto tra cittadino e Pubblica Amministrazione rendendo quest’ultima un alleato nella vita digitale dei cittadini. Qui risiede il punto focale della strategia: avvicinare la PA al cittadino ed alle aziende. Come? Snellendo i processi, ottimizzando i servizi, garantendo la non duplicazione dei dati, la loro sicurezza, rendendo i sistemi interoperabili. Con questo spirito i finanziamenti vanno a coprire anche gli ambiti più rilevanti della PA: una giustizia che sfrutti sempre più l’offerta di servizi digitali, una sanità che veda nel fascicolo sanitario del cittadino e nella telemedicina due fattori importanti di supporto alla popolazione, un comparto privato che possa contare su una PA che faciliti il proprio lavoro e non lo ostacoli con lungaggini burocratiche, una ricerca universitaria che abbia la capacità di parlare al mondo aziendale diventando hub di competenze e di innovazione.
Analizziamo quindi alcuni di questi ambiti partendo dalla digitalizzazione della PA. Se l’obiettivo dichiarato è “rendere la Pubblica Amministrazione la migliore alleata di cittadini e imprese, con un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili” occorre agire sia sull’ambito infrastrutturale che su quello applicativo, quindi dei servizi. Per fare questo il piano triennale da un lato spinge l’acceleratore sulla migrazione al cloud delle amministrazioni e all’efficientamento dei servizi, secondo il principio “once-only”, ovverossia non richiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già in possesso di qualsivoglia comparto della PA, garantendo il giusto livello di sicurezza e confidenzialità dei dati. Dall’altro lato vengono estesi i servizi ai cittadini migliorandone l’accessibilità e adeguando i processi prioritari delle Amministrazioni Centrali agli standard condivisi da tutti gli stati dell’Unione Europea. Soprattutto è molto importante – e qui si vede tutta l’arretratezza della macchina pubblica in termini di feudi e interessi locali nel digitale – «che la trasformazione digitale arrivi in periferia e non si fermi a livello centrale con un proliferare di sperimentazioni e piattaforme» – spiega Massimo Bollati, direttore per la Trasformazione Digitale dell’Agenzia del Demanio. Tutto bello: ma gli investimenti? Le risorse economiche ci sono: parliamo di 6,74 miliardi per la digitalizzazione della PA e di 6,71 miliardi per la realizzazione di reti ultraveloci. Secondo i dati del Dipartimento della Trasformazione Digitale pubblicati nel 2023, il piano per l’Italia Digitale dovrebbe portare il nostro Paese nel gruppo di testa in Europa entro il 2026. La strategia nazionale presuppone che siano raggiunti alcuni obiettivi. Innanzitutto dotare il 70% della popolazione della identità digitale, portare il 75% delle PA a utilizzare il cloud, mettere a disposizione online almeno l’80% dei servizi pubblici essenziali, connettere il 100% di cittadini ed imprese con reti ultraveloci.
Però prima di tutto occorre sottolineare che quello su cui occorre lavorare primariamente al di fuori degli investimenti tecnologici è l’alfabetizzazione informatica del cittadino e delle PMI, che sono la grande parte delle aziende che devono interagire con la PA. Se partecipare a una gara o bando pubblico è così complesso e articolato che solo una grande azienda con svariate decine o centinaia di addetti dedicati può parteciparvi, la sfida della trasformazione digitale della PA può considerarsi fallita prima di raggiungere l’obiettivo. Per restare in target occorre invece che il 70% della popolazione sia “digitalmente abile”.
REQUISITI, STANDARD E SILOS
Tenendo conto che attualmente, il 95% dei circa 11mila data center utilizzati dagli enti pubblici italiani sparsi sul territorio presenta carenze nei requisiti minimi di sicurezza, affidabilità, capacità elaborativa ed efficienza, l’approccio “cloud first” è stato finanziato con 900 milioni di euro proprio con il fine di razionalizzarli e consolidarli. Questo può avvenire con un processo di migrazione sul Polo Strategico Nazionale (PSN) con una nuova infrastruttura dedicata cloud (completamente privata o ibrida), localizzata sul territorio nazionale e all’avanguardia in prestazioni e sicurezza, oppure sul public cloud di uno tra gli operatori di mercato opportunamente certificati. Inoltre, siccome migrare al cloud non è proprio come cambiare auto ma comporta un pesante lavoro di analisi e attuazione di migrazione di dati, di riscrittura (in parte o in toto) di applicativi, un ulteriore plafond di un miliardo di euro è stato indirizzato per supportare le amministrazioni centrali e locali in questo processo.
Per facilitare l’orchestrazione di questa significativa mole di lavoro è stato creato un team dedicato a guida del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, incaricato di censire e certificare i fornitori idonei per ogni attività della trasformazione e, successivamente, di predisporre “pacchetti” e moduli standard (che ogni PA combinerà a seconda dei propri bisogni specifici). Per le PA locali minori, che non hanno la massa critica per una gestione individuale, verrà resa obbligatoria l’aggregazione in raggruppamenti ad hoc per l’esecuzione dell’attività di migrazione. La transizione al cloud è funzionale anche allo sviluppo di un ecosistema di imprese e startup in grado di integrare e migliorare l’offerta e la qualità di prodotti software per la PA. Oggi, le singole amministrazioni lavorano come tanti silos separati non interconnessi tra loro. La trasformazione digitale della PA si prefigge di cambiare l’architettura e le modalità di interconnessione tra le basi dati delle amministrazioni.
Avere banche dati pubbliche che parlano tra loro, contribuisce a un risparmio economico per le amministrazioni e di tempo per i cittadini. Once-only: per attuare questo concetto è necessario implementare e attuare il cosiddetto profilo digitale di ogni cittadino e impresa. Quindi basi dati distinte ma completamente interconnesse e interoperabili. Le risorse a disposizione sono 650 milioni di euro suddivisi su due ambiti: da un lato lo sviluppo e la messa in esercizio di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) al fine di garantire l’interoperabilità dei dati pubblici, dall’altro le attività di facilitazione alla implementazione di uno Sportello Digitale Unico, attuando il regolamento europeo che ha l’obiettivo di uniformare l’accesso ai servizi digitali in tutti i Paesi membri dell’UE.
Abbiamo già detto che uno degli obiettivi primari della trasformazione digitale della PA è semplificare la vita digitale dei cittadini e delle imprese, attraverso il miglioramento dei servizi pubblici. Il piano da 2,01 miliardi di euro prevede sei ambiti di azione: migliorare l’esperienza dei servizi pubblici digitali definendo e promuovendo l’adozione di modelli collaudati e riutilizzabili per la creazione di siti internet e l’erogazione di servizi pubblici digitali; migliorare l’accessibilità dei servizi pubblici digitali attraverso la diffusione di strumenti e strategie condivise: da test di usabilità ad attività di comunicazione e disseminazione passando per lo sviluppo di kit dedicati e altro; accelerare l’adozione di pagoPA, la piattaforma digitale per i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni, e dell’app IO quale principale punto di contatto tra enti e cittadini per la fruizione dei servizi pubblici digitali; favorire l’adozione dell’identità digitale (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID e Carta d’Identità Elettronica, CIE) e dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR); sviluppare e implementare la Piattaforma notifiche digitali degli atti pubblici, l’infrastruttura che le PA utilizzeranno per la notificazione di atti amministrativi a valore legale verso persone fisiche e giuridiche, contribuendo ad una riduzione di costi e tempo per cittadini ed enti; promuovere l’adozione di Mobility as a Service (MaaS) nei comuni per digitalizzare il trasporto locale e fornire ai cittadini un’esperienza di mobilità integrata: dalla pianificazione del viaggio ai pagamenti.
PA INTEROPERABILE
Dal 12 settembre 2025 entra in vigore in Italia il Regolamento (UE) 2023/2854 del Parlamento e del Consiglio Europeo, meglio noto come “Data Act”, e anche la pubblica amministrazione sarà impattata da queste nuove regole. Se si dovesse riassumere il contenuto del Data Act si potrebbe dire che chiarisce e regolamenta chi può raccogliere i dati – e quali – e conseguentemente come può utilizzarli. Ma attenzione. «Senza una tassonomia univoca e un’ontologia coerente, la condivisione dei dati resta priva di valore reale» avverte Bollati. Restringendo il campo al comparto pubblico è opportuno evidenziare che viene regolamentata l’interoperabilità e la governance dei dati stessi, nonché la possibilità e le modalità (anche dietro adeguata remunerazione) di interscambio di dati tra privato e pubblico. Una figura centrale di “garante” dei dati dovrebbe essere istituita al fine di consentire la corretta attuazione delle regole del Data Act. L’attuazione piena del Data Act potrà portare una serie di benefici che vanno dalla disponibilità di dati su cui prendere decisioni e la possibilità di accedere a dati posseduti da aziende private con oneri regolamentati, fino all’utilizzo di standard europei per l’interoperabilità.
Come riportato dal sito AgID grazie alle nuove linee guida del PDND emanate a giugno 2025, l’interoperabilità si arricchisce di funzionalità evolute per rendere maggiormente sicuro lo scambio di dati e introduce altri strumenti di cooperazione, rendendo la piattaforma più efficiente e aperta. Il nuovo impianto normativo e tecnico mira a rendere l’interoperabilità tra gli enti più efficiente, con impatti concreti su servizi, processi e tempi di risposta per pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese, favorendo una PA più integrata e orientata al cittadino. A garanzia della corretta gestione dei dati occorre evidenziare che, secondo quanto previsto dall’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), al fine di garantire solidità, conformità e trasparenza, il percorso di aggiornamento ha incluso una consultazione pubblica del testo e dei relativi allegati, seguita da una revisione tecnica e istituzionale che ha coinvolto il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza Unificata e la Commissione Europea. Maggiore sicurezza, semplificazione e standardizzazione, efficienza e cooperazione applicativa, monitoraggio e migliore gestione interna: passi verso un ecosistema digitale aperto. Tra le principali novità introdotte dalla nuova versione delle Linee Guida per la PDND spicca l’apertura della piattaforma anche ai soggetti privati, che potranno aderire e operare, nell’ambito di attività connesse a finalità di interesse pubblico, sia come Fruitori sia come Erogatori di servizi. La PDND si configura così come un canale istituzionale, sicuro e standardizzato per lo scambio di dati tra Pubblica Amministrazione e settore privato, favorendo la nascita di un ecosistema digitale integrato e abilitando servizi più connessi, efficienti e accessibili per cittadini e imprese.
INSIEME PER LA CRESCITA
È noto che la digitalizzazione accresce in modo significativo la vulnerabilità dei dati, siano essi del cittadino, delle imprese o delle istituzioni pubbliche. Al tema della cybersecurity sono destinati 620 milioni di euro. Se le amministrazioni locali sono quelle che faticano di più a trovare i finanziamenti corretti per la loro trasformazione digitale, sono le grandi amministrazioni centrali quelle che giocano un ruolo fondamentale nell’offerta di servizi pubblici efficienti e snelli. Interventi mirati del valore di 610 milioni di euro sono stati messi in cantiere proprio per la digitalizzazione di questi colossi: Inps, Ministero della Giustizia, Inail, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Guardia di Finanza, Consiglio di Stato.
All’Inps vanno 180 milioni per la revisione di sistemi e procedure interne. Al Ministero della Giustizia vanno 133,2 milioni per la digitalizzazione degli archivi relativi ai procedimenti civili dei Tribunali ordinari, delle Corti d’appello e degli atti giudiziari di Cassazione, creazione di un data lake per l’estrazione e l’organizzazione degli orientamenti giurisprudenziali, di analisi statistiche avanzate, anche sulla base di dati non strutturati contenuti nei documenti, per monitorare l’efficienza e l’efficacia del sistema giudiziario ed ottimizzare la gestione dei tempi di istruttoria. All’Inail spettano 116 milioni per la digitalizzazione dei processi e dei servizi istituzionali e l’adozione di un digital workplace. Per la digitalizzazione dei servizi al cittadino e dei processi interni, sviluppo di applicazioni e sistemi gestionali interni e riqualificazione delle capacità digitali del personale vanno al Ministero dell’Interno 107 milioni. Il consolidamento dell’infrastruttura digitale, potenziamento della sicurezza delle informazioni e migrazione delle applicazioni legate alla gestione del personale verso un paradigma open source costerà al Ministero della Difesa 42,5 milioni di euro.
La Guardia di Finanza riceverà 25 milioni di euro per potenziare l’attività di prevenzione e contrasto dei reati finanziari attraverso la data science. L’investimento punta a evolvere i sistemi informativi del Corpo grazie all’introduzione di algoritmi di intelligenza artificiale e modelli di analisi predittiva e prescrittiva. Infine il Consiglio di Stato avrà 7,5 milioni per il potenziamento del sistema informativo della Giustizia Amministrativa mediante l’implementazione di un sistema di conservazione a norma per la custodia dei documenti giurisdizionali, di un data warehouse con funzionalità evolute di business intelligence per analisi statistiche georeferenziate e predittive, applicazioni di intelligenza artificiale per l’efficientamento dei processi di lavoro e l’innalzamento dei livelli di sicurezza informatica.
In coda alla lista della spesa, appena 200 milioni di euro sono stati stanziati per sviluppare le competenze digitali dei cittadini. Una cifra limitata, se confrontata con le altre voci di spesa, a fronte di un obiettivo fondamentale: garantire che la trasformazione digitale della PA sia davvero accessibile a tutti. A tal fine sono state definite due iniziative: l’istituzione del Servizio Civile Digitale con la formazione di circa diecimila volontari a supporto di oltre milione di cittadini, e l’ampliamento dei Centri di Facilitazione Digitale, veri e propri punti fisici dove il cittadino può formarsi sulle competenze digitali.
La vera sfida, quindi, non riguarda solo i software e le piattaforme. Riguarda anche e soprattutto la cultura organizzativa. Digitalizzare senza ripensare i processi rischia di replicare in formato elettronico inefficienze già esistenti. È necessario invece un ripensamento profondo, che metta al centro il cittadino e la semplificazione delle procedure. In questo percorso, la formazione dei dipendenti pubblici è decisiva: non si tratta di sostituire l’essere umano con la macchina, ma di fornire strumenti che rendano il lavoro più efficace e permettano di offrire servizi migliori. La trasformazione digitale è, in definitiva, una grande opportunità per ricostruire il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Una Pubblica Amministrazione che si mostra più trasparente, efficiente e attenta alle esigenze delle persone non solo migliora i propri servizi, ma ha un impatto positivo sul PIL e contribuisce a rafforzare la coesione sociale e a stimolare la partecipazione civica.
L’INFRASTRUTTURA DI RETE
Sanità, trasporti, scuola, giustizia, enti locali e inclusione: in ciascuno di questi ambiti le potenzialità sono enormi. Ma la vera rivoluzione non sarà solo tecnologica: sarà culturale. Perché digitalizzare non significa caricare i vecchi processi su una piattaforma online, ma ripensarli a partire dai bisogni delle persone. Tutto questo, però, avrà senso solo se i servizi saranno realmente accessibili a tutti, indipendentemente dal luogo: dalla metropoli al borgo montano, fino alle isole minori. Per questo motivo occorre lavorare primariamente sulla infrastruttura di rete. La nuova strategia europea “Digital Compass” stabilisce obiettivi impegnativi per il prossimo decennio: deve essere garantita entro il 2030 una connettività a 1 Gbps per tutti e la piena copertura 5G delle aree popolate. L’ambizione italiana, come riportato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale è di raggiungere gli obiettivi europei di trasformazione digitale in netto anticipo sui tempi, portando connessioni a 1 Gbps su tutto il territorio nazionale entro il 2026. Gli investimenti sono stati inseriti nel PNRR, ora bisogna vedere se verranno rispettate le scadenze. Il piano prevede una dotazione economica di 3,8 miliardi di euro per garantire la connettività ad almeno 1 Gbps in download e 200 Mbit/s in upload alle unità immobiliari che lo necessitano e che al 2026 non sarebbero state coperte da investimenti privati in grado di garantire una velocità di connessione di almeno 300 Mbps in download. La domanda sospesa però rimane la seguente: e quelle unità che già hanno tale connessione quando avranno il gigabit?
L’Italia è stata il primo Paese nell’Unione ad aver assegnato diritti d’uso dello spettro radio in tutte le tre bande di frequenze per lo sviluppo del 5G posizionandola ai primi posti nell’indice DESI della Commissione europea con riferimento al parametro “5G readiness”. Il piano prevede quindi uno stanziamento di 2,02 miliardi con l’obiettivo di “incentivare la diffusione di reti mobili 5G nelle aree a fallimento di mercato, al fine di soddisfare pienamente il fabbisogno di connettività mobile e di fornire servizi mobili innovativi e ad elevate prestazioni”. In altre parole: dove non si arriva con il gigabit si sopperirà con la connettività mobile 5G.
A completamento occorre sottolineare che il piano prevede anche investimenti per progetti di interesse nazionale. Spiccano i progetti che riguardano le scuole e la sanità pubblica. Entro il 30 giugno 2026, grazie a una dotazione economica di 261 milioni di euro per le scuole e di 501 milioni per la sanità pubblica, questi comparti dovrebbero beneficiare di una connessione ultraveloce insieme alla fornitura di servizi di gestione e manutenzione per i sei anni successivi.
LA STRATEGIA ITALIANA PER L’AI
Negli ultimi anni il termine intelligenza artificiale è entrato con forza nel dibattito pubblico, spesso associato a scenari futuristici o a rivoluzioni tecnologiche che cambieranno il nostro modo di vivere e lavorare. Ma l’intelligenza artificiale non è più soltanto una prospettiva lontana: è una realtà concreta, già applicata in molti settori, che può portare benefici immediati anche nella vita quotidiana dei cittadini. Uno degli ambiti in cui il suo potenziale è più evidente è proprio quello della Pubblica Amministrazione, dove l’innovazione digitale non è solo auspicabile, ma necessaria per offrire servizi moderni, semplici ed efficienti. Sfruttare le enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale rappresenta una opportunità. L’AI, se guidata da principi di trasparenza e responsabilità, può essere il motore di questa rivoluzione, contribuendo a realizzare una trasformazione digitale autentica ed efficace della PA.
Nel rapporto pubblicato nel 2025, l’AgID rileva che, su 108 organizzazioni interpellate, 45 hanno già avviato oltre 120 progetti nel secondo semestre 2024: 50 riguardano le infrastrutture sociali e sostenibili, i restanti 70 altri settori applicativi. A fine luglio 2024 è stata presentata la “Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026”, un documento redatto da un comitato di esperti per supportare il Governo nella definizione di una normativa nazionale e delle politiche sull’AI. Come riportato dall’AgID, dopo un’analisi del contesto globale e del posizionamento italiano, il documento definisce le azioni strategiche, raggruppate in quattro macroaree: Ricerca, Pubblica Amministrazione, Imprese e Formazione. La strategia propone un’analisi del contesto regolativo che traccia la cornice entro cui dovrà essere dispiegata. Come scritto nella versione aggiornata al 2025, il Piano triennale 2024-2026 presenta alcuni cambiamenti nella sua struttura, rispetto alle edizioni precedenti; inoltre, alcuni contenuti sono stati approfonditi per sostenere in modo efficace le pubbliche amministrazioni nel processo di implementazione e gestione dei servizi digitali. L’introduzione delle tecnologie non porta a cambiamenti se non si ripensa l’organizzazione dei procedimenti e l’attività amministrativa, con una revisione dei processi delle amministrazioni secondo il principio once-only.
La strategia prevede anche un sistema di monitoraggio e analisi del contesto regolatorio, che definisce la cornice entro cui dovrà essere attuata. Un’attività che l’AgID ha già avviato, fissando come obiettivo 150 progetti di innovazione basati sull’IA entro il 2025 e circa 400 entro il 2026. Il documento evidenzia come l’intelligenza artificiale stia diventando sempre più efficace nel migliorare l’operatività della Pubblica Amministrazione, ottimizzando i processi, riducendo gli errori e aumentando la qualità di prodotti e servizi, con un impatto positivo sull’esperienza dei cittadini nel rapporto con le istituzioni. Per far leva sull’intelligenza artificiale, le Pubbliche Amministrazioni devono essere accompagnate nell’acquisizione e progettazione di sistemi AI, superando la carenza di competenze specialistiche. Parallelamente, è necessario realizzare infrastrutture informatiche sicure, affidabili e robuste, anche attraverso piattaforme nazionali che assicurino efficienza e qualità tecnologica.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati, la strategia per la Pubblica Amministrazione delinea sei piani di azione principali. Primo passo: guidare la PA attraverso linee guida che evidenzino le potenzialità e l’utilizzo delle piattaforme di AI, supportate da case study concreti e dalla promozione di best practice. Secondo passo: orientare le amministrazioni nell’attività di procurement di soluzioni AI, sia attraverso gare d’appalto sia mediante specifici accordi quadro, garantendo che rispondano alle esigenze funzionali, rispettino le normative e assicurino adeguati livelli di sicurezza.
Terzo passo: sviluppare applicazioni coerenti con le linee strategiche nazionali, privilegiando piattaforme sviluppate in Italia. Questi progetti dovranno garantire piena aderenza alle normative nazionali e UE, con particolare attenzione alla gestione dei rischi e alla tutela dei dati personali; considerare le esigenze derivanti da settori strategici e critici, come energia, difesa e intelligence; promuovere iniziative di formazione del personale, aumentando le competenze su soluzioni tecnologiche avanzate e processi certificabili, scalabili e condivisibili a livello nazionale.
Quarto e quinto passo: definire linee guida per progettare strumenti e metodologie che facilitino l’interazione con i cittadini e per rendere più efficienti i processi interni, attraverso lo sviluppo o l’adozione di sistemi di IA, a partire dalla mappatura dei sistemi e servizi già esistenti.
Sesto passo: promuovere percorsi di upskilling per il personale in servizio, con la creazione di un dipartimento dedicato all’intelligenza artificiale incorporato nella Scuola Nazionale dell’Amministrazione, con l’attivazione di corsi post-laurea di eccellenza, differenziati per livello e contenuti in base alle funzioni dei dipendenti coinvolti. L’AI può trasformare la Pubblica Amministrazione, rendendo i processi più efficienti, veloci e sicuri, se guidata da trasparenza e principi di sicurezza. Il vero vantaggio non sta solo nella tecnologia, ma nella capacità di inserirla in un modello di governance centrato su cittadini e imprese, supportato da una connettività capillare che permetta a tutti di sfruttare appieno gli investimenti realizzati.