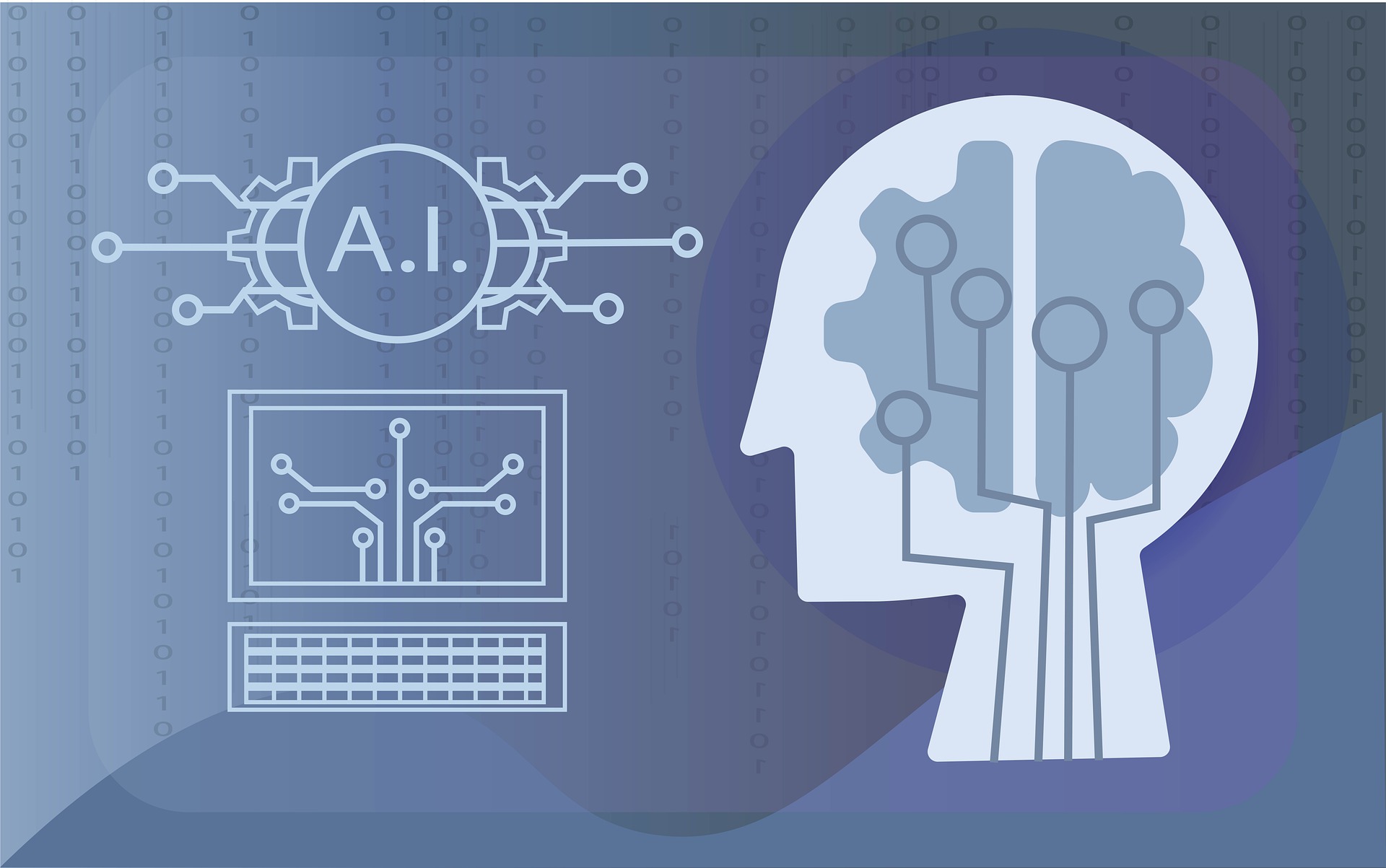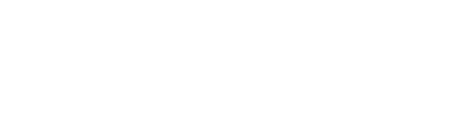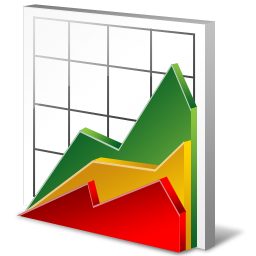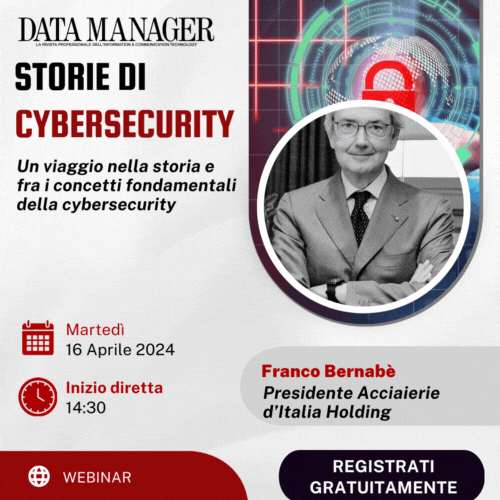L’AI generativa avanza nelle grandi organizzazioni europee e statunitensi, con oltre la metà che l’ha già integrata nei workflow. In Italia, sperimentazioni frammentate e progetti incompleti rallentano il passaggio dall’hype alla produttività. Buona o cattiva notizia?
La risposta non è semplice né univoca. La velocità di adozione dell’AI generativa è spinta da una pressione competitiva crescente: restare indietro significa rischiare un arretramento strutturale rispetto ai peer internazionali, soprattutto nei settori a maggiore intensità di conoscenza. I Large language models (LLMs) stanno già ridisegnando processi, modelli operativi e catene del valore, e un’adozione tardiva può amplificare un gap di produttività che in Italia è da tempo un nodo irrisolto.
Allo stesso tempo, il dibattito più maturo sull’AI suggerisce che correre non basta. Molte organizzazioni che hanno adottato i LLM in modo accelerato si confrontano oggi con limiti concreti: dati di scarsa qualità, costi infrastrutturali sottovalutati, problemi di governance, sicurezza e affidabilità dei modelli. In questo contesto, un approccio da fast follower può trasformarsi in un vantaggio: osservare gli errori altrui, evitare scelte tecnologiche premature e investire su basi più solide – dati, competenze e architetture – prima di scalare.
La vera discriminante, quindi, non è la velocità in sé, ma la capacità di trasformare l’adozione dell’AI generativa in produttività misurabile. Per l’Italia, la sfida non è decidere se accelerare o attendere, ma quando e come farlo, evitando che la prudenza si trasformi in immobilismo e che l’entusiasmo si traduca in nuove inefficienze.
L’AI PER LA PRODUTTIVITÀ
Continua a stagioni alternate il lungo inverno della produttività in Italia, che dal 1995 al 2024 è cresciuta con una lentezza strutturale: in media appena lo 0,3% l’anno. Uno “zero virgola” che è la fotografia di un ritardo certificato dai dati Istat per il 2024: la produttività arretra ancora, segnando un -1,9 per cento. Un calo meno brusco rispetto al -2,7 per cento del 2023, ma che non cambia la sostanza. Il segno resta negativo e racconta una difficoltà cronica del sistema produttivo italiano. Per rendersi conto di quanto pesante sia la zavorra che rallenta l’economia italiana basta spostare lo sguardo oltre i confini nazionali.
Tra il 1995 e il 2024, mentre l’Italia avanzava al passo minimo dello 0,3 per cento l’anno, i nostri principali competitor viaggiavano a velocità di tre o quattro volte superiori. La produttività del lavoro nell’Unione europea (EU27) è cresciuta in media dell’1,45 per cento annuo, in Germania dell’1,2 per cento, in Francia dell’1,0. In trent’anni, questo scarto si è trasformato in un divario strutturale di efficienza. Se guardiamo al solo 2024 la dinamica è chiara: l’Italia continua ad assorbire lavoro senza riuscire a trasformarlo in valore. Nel 2024 le ore lavorate sono aumentate del 2,3 per cento, ma il valore aggiunto – cioè la ricchezza effettivamente prodotta dai settori che producono beni e servizi di mercato – si è fermato a un timido +0,4 per cento, in forte rallentamento rispetto all’anno precedente. La forbice tra ore lavorate e output generato si traduce inevitabilmente in un nuovo calo della produttività del lavoro, pari all’1,9 per cento. E arretra anche la Produttività Totale dei Fattori (PTF) – l’indicatore che misura l’efficienza complessiva del sistema e la capacità di innovare i processi – in flessione dell’1,2 per cento.
Il paradosso si fa ancora più evidente se si guardano gli investimenti. Nel 2024 l’input di capitale delle imprese italiane è cresciuto dello 0,5 per cento: aumentano gli investimenti in ICT, cresciuti del +4,1% per un valore complessivo di 42,4 miliardi di euro secondo i dati Assintel, ma anche quelli in capitale immateriale: ricerca e sviluppo, software, proprietà intellettuale. Eppure il salto di qualità, inteso come aumento dell’efficienza aggregata, non arriva. La produttività del capitale arretra, mostrando che l’adozione delle nuove tecnologie è ancora in una fase di transizione costosa e incompleta.
A partire da questi numeri, che cosa può fare in concreto l’intelligenza artificiale generativa per migliorare la produttività? Prima di azzardare una risposta, è però utile fare un passo indietro. Per capire dove l’AI può incidere concretamente – e dove, invece, rischia di restare un’illusione tecnologica – conviene osservare come si stanno muovendo le grandi organizzazioni a livello internazionale. Qual è il grado reale di adozione? In quali funzioni la Gen AI è già entrata? E con quali risultati misurabili?
Per rispondere a queste domande, vale la pena affidarsi a due osservatori privilegiati del cambiamento in corso, le ricerche di McKinsey e Deloitte, che da anni monitorano l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali globali. I loro dati non raccontano una rivoluzione improvvisa, ma una trasformazione progressiva, fatta di sperimentazioni, correzioni e, soprattutto, di lezioni apprese sul campo. Un punto di partenza solido per capire che cosa l’AI può realisticamente fare, oggi, per la produttività.
L’IRRESISTIBILE ASCESA
Dal 2023 l’intelligenza artificiale generativa ha smesso di essere un terreno di sola sperimentazione, entrando progressivamente nell’operatività quotidiana delle imprese a livello globale, seppure con modalità e intensità diverse, che variano da un settore industriale all’altro. Il 2025 da questo punto di vista segna un’accelerazione significativa nell’adozione dell’AI da parte delle imprese.
L’AI fa sempre più spesso il suo ingresso nelle funzioni operative e inizia a incidere concretamente sul lavoro quotidiano. Eppure, dietro la narrazione della corsa all’AI, per una quota significativa di imprese, l’adozione rimane ancora ferma alla fase sperimentale. A dirci in estrema sintesi tutto questo è l’ultimo report McKinsey, The State of AI in 2025: Agents, Innovation, and Transformation, che fotografa un’adozione in crescita e al tempo stesso una capacità ancora limitata di integrare l’intelligenza artificiale nei processi chiave.
I numeri di McKinsey raccontano una diffusione ormai capillare dell’intelligenza artificiale nelle imprese: l’88 per cento delle aziende la utilizza con regolarità almeno in una funzione, un balzo significativo rispetto al 78 dell’anno precedente. Ma dietro questa penetrazione quasi universale si nasconde una maturità ancora diseguale. Solo una minoranza, circa un terzo delle aziende interpellate, ha iniziato a portare l’AI a scala enterprise, mentre la maggior parte resta bloccata in una zona intermedia fatta di test, sperimentazioni e progetti pilota che faticano a trasformarsi in strategia chiara di adozione su larga scala.
I grandi gruppi avanzano più velocemente, mentre le imprese più piccole arrancano. Quasi la metà di quelle con oltre 5 miliardi di dollari di ricavi ha raggiunto la fase di scaling, contro appena il 29 per cento tra quelle sotto i 100 milioni. La buona notizia è che l’AI non è più confinata a una singola divisione. Il 68 per cento delle aziende la utilizza in più di una funzione e una su due in almeno tre, segno di una diffusione sempre più trasversale, dall’IT alla gestione della conoscenza, dal marketing alle vendite.
Tra le novità più significative, spiccano gli AI agent, sistemi costruiti su modelli fondamentali in grado non solo di generare contenuti, ma di pianificare azioni, concatenare più passaggi operativi e intervenire in contesti reali con un certo grado di autonomia. I dati indicano un interesse già molto diffuso, con una larga maggioranza (62%) delle imprese che ha avviato sperimentazioni su questi strumenti. Tuttavia solo una quota ridotta (23%) ha iniziato a distribuirli su scala aziendale, e quasi sempre in ambiti circoscritti. Il fatto che in nessuna funzione il livello di adozione estesa superi la soglia del 10 per cento segnala chiaramente che ci troviamo ancora in una fase iniziale.
I casi d’uso più maturi dell’AI generativa emergono dove l’integrazione è più naturale e il rischio è più gestibile: nelle funzioni IT – dalla service desk automation al triage tecnico – e nella gestione della conoscenza, tra ricerca avanzata, document retrieval e sintesi automatizzata. L’adozione è più avanzata anche nei settori digitalmente maturi, come media, telecomunicazioni, finance e sanità, seppur con approcci selettivi e fortemente governati nei contesti più regolati.
Una delle domande chiave del rapporto McKinsey riguarda la capacità dell’AI di produrre benefici realmente misurabili. La risposta è affermativa, ma non priva di distinguo. Il 39 per cento degli intervistati dichiara che l’AI ha già avuto un impatto sull’EBIT aziendale (Earnings Before Interest and Taxes), cioè l’utile prima degli interessi e delle imposte. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il contributo resta limitato, con meno del 5 per cento dell’EBIT complessivo direttamente attribuibile all’adozione dell’AI. Dove i risultati appaiono invece più netti è sul piano qualitativo con il 64% delle aziende registra un miglioramento dei processi di innovazione, mentre il 45% riscontra un aumento della soddisfazione del cliente. La stessa percentuale (45%) riconosce all’AI la capacità di generare un vantaggio competitivo concreto. Le aree in cui l’impatto è più evidente si distribuiscono lungo due direttrici principali. La riduzione dei costi, che interessa soprattutto software engineering, IT e produzione, e l’aumento dei ricavi, trainato da marketing e vendite, strategia e corporate finance, sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
Nel report McKinsey emerge con chiarezza un gruppo ristretto di aziende che si distingue dalla media. Sono quelle che attribuiscono all’intelligenza artificiale almeno il cinque per cento del proprio EBIT e che dichiarano di trarne un valore significativo. Ciò che le accomuna non è tanto la tecnologia in sé, quanto l’approccio. A differenza della maggioranza delle imprese, che continua a considerare l’AI soprattutto come uno strumento di efficientamento, gli high performer la utilizzano come leva di crescita e di trasformazione del modello di business, risultando tre volte più inclini a impiegarla per guidare cambiamenti radicali.
La differenza si vede anche nel modo in cui affrontano i processi. Invece di limitarsi ad automatizzare attività esistenti, ripensano i workflow alla radice, integrando l’AI nei flussi operativi e nei sistemi decisionali. Questo salto è sostenuto da una leadership esplicita e coerente. Nelle aziende più avanzate il commitment del top management è dichiarato, continuo e tre volte superiore rispetto alla media.
A questa visione corrispondono investimenti più consistenti. Circa un terzo di queste imprese destina oltre il 20 per cento del budget digitale all’AI, contro appena il sette per cento delle altre. Non sorprende, quindi, che siano anche più avanti nell’adozione dell’AI agentica. Il tutto avviene all’interno di un impianto organizzativo strutturato, fatto di strategie chiare, governance solida, gestione dei dati, modelli operativi coerenti e formazione continua. In questo quadro, la presenza umana resta centrale, grazie a pratiche human-in-the-loop, che stabiliscono quando l’intervento umano è necessario per supervisionare, validare o correggere l’output dei sistemi intelligenti.
Gli analisti McKinsey estendono l’analisi oltre la dimensione economica, osservando come l’intelligenza artificiale stia incidendo sulla forza lavoro e sulla gestione dei nuovi profili di rischio. Sul piano occupazionale, il 43 per cento delle aziende non prevede cambiamenti significativi, mentre il 32 per cento si attende una riduzione degli organici e il 13 per cento ipotizza un aumento dell’occupazione, segno di una trasformazione ancora in corso e non omogenea. Parallelamente, cresce in modo deciso la domanda di competenze specialistiche in ambito AI, in particolare per software engineer e data engineer, con una dinamica più accentuata nelle organizzazioni di maggiori dimensioni.
Sul fronte del rischio, le imprese gestiscono oggi in media quattro criticità legate all’AI, il doppio rispetto al 2022, e oltre la metà (51%) dichiara di aver già sperimentato impatti negativi. La criticità più frequente riguarda l’inesattezza dei risultati prodotti dai sistemi, seguita da problemi di compliance normativa e di proprietà intellettuale. Anche in questo caso, emerge una linea di demarcazione netta tra le aziende. I top performer, pur essendo più esposti per via di un uso più avanzato dell’AI, risultano anche più efficaci nella mitigazione dei rischi, grazie a modelli di gestione strutturati che includono pratiche di auditing, validazione e controllo continuo. Il report McKinsey si conclude con una metafora che sintetizza efficacemente lo stato dell’adozione dell’AI nelle imprese: se fosse una maratona, molte organizzazioni si troverebbero ancora sulla linea di partenza. Gli strumenti sono disponibili, ma mancano la revisione profonda dei processi, una leadership realmente ingaggiata e una strategia capace di sostenere l’intero percorso competitivo.
L’IMPATTO DELL’AI IN ITALIA
L’intelligenza artificiale entra anche nelle imprese italiane. I numeri Istat raccontano una crescita impetuosa: in un solo anno l’uso dell’AI raddoppia, passando dall’8,2 per cento del 2024 al 16,4 per cento del 2025 tra le imprese con almeno dieci addetti. Solo due anni fa era ferma al cinque per cento. Un segnale di accelerazione reale, ma anche dell’inizio di una nuova frattura. Se si guarda alla dimensione aziendale, a correre sono soprattutto le grandi imprese: oltre la metà (53,1%) ha utilizzato almeno una tecnologia di AI, contro il 32,5 per cento dell’anno precedente. Le PMI migliorano, raddoppiano anch’esse, ma restano indietro, passando dal 7,7 al 15,7 per cento. Un divario che si allarga. In due anni la distanza nell’uso dell’AI è passata da 20 a 37 punti percentuali, in controtendenza rispetto ad altri fronti della digitalizzazione – cloud, software gestionali, analisi dei dati – dove le differenze si stanno lentamente riducendo. Nel caso dell’AI, invece, l’utilizzo premia chi è già strutturato e penalizza chi fatica a investire in competenze, data quality e governance.
Come spesso accade, non tutte le industry viaggiano alla stessa velocità. L’analisi dei dati e l’uso dell’AI sono più diffusi nei settori ad alta intensità informativa: energia, servizi di informazione, professioni tecniche. Qui l’AI diventa uno strumento naturale di ottimizzazione, previsione, supporto decisionale. Altrove la digitalizzazione assume forme più “commerciali”. Social media e vendite online dominano nel commercio e nel turismo. Sul fronte europeo, l’Italia migliora. Gli obiettivi del “Decennio Digitale” non sono più un miraggio. Nel corso del 2025, quasi l’80 per cento delle imprese ha raggiunto almeno un livello base di digitalizzazione. Tra le grandi imprese la soglia è praticamente universale. Anche il target del 90 per cento delle PMI digitalizzate entro il 2030 appare ormai a portata di mano. Ma sugli obiettivi più ambiziosi – cloud avanzato, analisi dei dati, e appunto AI – il percorso è ancora in salita.
Oltre la metà delle imprese sperimenta soluzioni di AI generativa, la tecnologia più visibile, accessibile e trasversale. L’AI viene usata soprattutto per estrarre informazioni dai testi, generare contenuti, analizzare linguaggio e immagini. Seguono il riconoscimento vocale e, più indietro, il machine learning classico.
IT, media e telco, trainano la crescita. Gli ambiti aziendali in cui l’AI viene maggiormente utilizzata sono marketing e vendite (33,1%), organizzazione dei processi amministrativi (25,7%), ricerca e sviluppo (20,0%). Aree che, rispetto al 2024, registrano gli incrementi più significativi in termini di imprese coinvolte, con aumenti superiori al 60% (rispettivamente: +92,6%, +89,4% e +68,9%). Anche la sicurezza informatica emerge come uno dei campi più maturi, soprattutto nelle grandi imprese (43,7%) dei settori telecomunicazioni (38,4%) ed energia (28,2%), dove l’uso di modelli predittivi è entrato in maniera più strutturale. Un terzo delle imprese dichiara di usare l’AI ma non sa indicare con precisione per quale finalità aziendale. Diffusa soprattutto tra le piccole imprese (l’83,3% di imprese con 10-49 addetti) – è l’AI non riconducibile ad alcun ambito aziendale definito, spesso sperimentale, frammentata, non integrata e poco strutturata.
Cresce la quota di aziende che, pur avendo valutato l’adozione dell’AI, ha scelto di non procedere, rinunciando a integrarla nei propri processi, almeno in questo momento. Non solo per i costi e per la complessità della tecnologia, ma soprattutto per la mancanza di competenze, citata da quasi sei imprese su dieci. Seguono l’incertezza normativa, la qualità dei dati, i timori su privacy e sicurezza. Un quarto delle aziende solleva anche questioni etiche. C’è infine una minoranza stabile (14,8%, lievemente superiore al 14,3 del 2023), che ritiene l’AI semplicemente inutile. Il segnale che quando una tecnologia appare lontana dai problemi quotidiani, smette di essere una soluzione.
LA DIFFERENZA DI POTENZIALE
Aspettative legate allo sfruttamento dell’intelligenza artificiale continuano a rimanere alte a ogni latitudine. Eppure, secondo l’ultimo rapporto State of AI in the Enterprise 2026 di Deloitte, l’AI resta in gran parte una promessa mantenuta a metà. Oltre 3.200 dirigenti di alto livello, in 24 paesi e sei settori industriali, raccontano un mondo in cui l’adozione dell’AI accelera rapidamente, ma di trasformazione vera e propria è ancora prematuro parlare. Le aziende hanno un accesso sempre più ampio agli strumenti AI, ma faticano a trasformarlo in valore diffuso, strutturale e duraturo.
Andiamo con ordine. Nel giro di un solo anno, l’impiego di strumenti di AI è cresciuto di circa il 50%. Oggi quasi sei lavoratori su dieci usano strumenti di AI nel proprio lavoro. In alcune organizzazioni più avanzate, l’AI è disponibile per oltre l’80% della forza lavoro. Meno del 60% però degli utilizzatori la utilizza con continuità. Non diventa abitudine e non cambia il modo in cui le persone prendono decisioni. Solo un’azienda su quattro riesce a portare in produzione almeno il 40% dei progetti di AI avviati.
Le altre restano intrappolate in proof of concept con il corollario inevitabile di team ridotti e orizzonti brevi. Quando però l’AI deve entrare davvero nei processi aziendali, il tempo si dilata. Quello che doveva durare tre mesi diventa un progetto da un anno e mezzo. Servono integrazioni con sistemi legacy, verifiche di sicurezza, controlli legali, manutenzione continua. E spesso manca una strategia chiara per affrontare questi passaggi. L’AI funziona soprattutto come moltiplicatore di efficienza. Il 66% delle aziende interpellate segnala aumenti di produttività, il 53% parla di decisioni migliori, il 38% di riduzioni dei costi. Numeri che spiegano perché gli investimenti continuano. Tre aziende su quattro sperano che l’AI generi nuova crescita dei ricavi. Solo una su cinque però dice che sta già succedendo. La maggioranza usa l’AI per fare meglio ciò che faceva prima, non per ripensare il proprio business in modo diverso o semplicemente per fare cose diverse. Solo il 34 per cento delle imprese dichiara di usare l’AI per trasformare in profondità prodotti, processi o modelli di business. Le altre si limitano a ritocchi superficiali. È qui che si crea il vero gap competitivo tra chi usa l’AI come una protesi e chi la tratta in modo più maturo e lungimirante.
Si parla molto di automazione, ma ancora in poche realtà si ha la capacità di ridisegnare il lavoro. L’84% delle aziende non ha ancora ben chiaro come cambieranno i ruoli professionali alla luce dell’implementazione dell’AI. Eppure le stesse aziende prevedono che, entro tre anni, oltre l’80% dei posti di lavoro subirà forme di automazione significativa. Si investe in “alfabetizzazione dell’intelligenza artificiale”, ma molto meno in nuove carriere, nuovi team, nuovi modelli organizzativi.
Tra i lavoratori solo una minoranza si professa entusiasta, mentre la maggior parte guarda al fenomeno con prudenza quando non con aperta diffidenza. Nel rapporto Deloitte, il termine “worker” include l’intera forza lavoro. Tuttavia, l’espansione dell’accesso all’AI riguarda oggi soprattutto i knowledge worker, mentre nei contesti “blue collar” l’adozione è più indiretta e legata a casi d’uso specifici.
Inoltre si sottolinea come l’AI non elimina il lavoro umano, ma ne cambia la natura. Aumenta il bisogno di giudizio, supervisione, responsabilità, in particolare mentre i sistemi diventano sempre più autonomi. Ma questo salto non avviene da solo. Va progettato. Una parte significativa del rapporto mette in luce l’ascesa dell’AI agentica. Confermando quanto già rilevato dal report McKinsey, quasi un quarto delle aziende dichiara di utilizzarla già in modo consistente, ed entro due anni saranno tre su quattro. La maggior parte delle organizzazioni (85%) prevede inoltre di personalizzare gli agent AI per adattarli alle proprie specifiche esigenze di business. Tuttavia, solo il cinque per cento delle aziende è riuscito a integrarli come componenti operative core, e appena una su cinque dispone di modelli maturi di governance e controllo per questi sistemi.
Non si tratta di un dettaglio. Perché le principali paure delle imprese riguardano proprio ciò che l’AI agentica amplifica: sicurezza dei dati, conformità normativa, responsabilità delle decisioni. Il pericolo è che le aziende si interfaccino con l’AI adottando una logica di mero potenziamento. Con il rischio di restare intrappolate nella gestione efficiente del passato. Al contrario in questa fase di profonda discontinuità, l’introduzione di nuove tecnologie richiede architetture pensate per evolvere, non sistemi legacy rattoppati. Usare l’AI solo per rafforzare l’attuale IT significa rinunciare a progettare il futuro.
Per molte aziende infine uno dei freni principali ad investire è la difficoltà di misurare un ritorno sull’investimento immediato. Nell’incertezza, molte aziende cedono alla tentazione di rallentare, aspettare, contenere gli investimenti. Ma un ROI inizialmente deludente non significa automaticamente che la tecnologia sia immatura. La vera domanda è un’altra: in una fase di cambiamento così radicale, ha senso chiedere alle persone e alle architetture esistenti di evolvere, riducendo al contempo le risorse necessarie per farlo?
OPPORTUNITÀ E LIMITI
L’AI funziona davvero quando si cambia il modo di lavorare. L’Italia convive da trent’anni con un problema che non è ciclico, ma strutturale. La produttività non cresce perché non basta lavorare, investire o digitalizzare di più. Serve lavorare in modo diverso. In questo spazio stretto l’intelligenza artificiale può fare qualcosa di molto concreto, ma anche molto limitato, se le si chiede ciò che non può dare.
La domanda corretta quindi, non è se l’AI “salverà” la produttività italiana, ma dove può realisticamente incidere. Già negli anni Ottanta Robert Solow, tra i più autorevoli economisti del Novecento, osservava come l’era dei computer fosse visibile ovunque tranne che nelle statistiche sulla produttività. Un paradosso che rischia di riproporsi anche con l’intelligenza artificiale. Eppure, quando l’AI viene correttamente integrata nei processi di lavoro, è in grado di ridurre sprechi invisibili di tempo e attenzione, generando efficienza.
A confermarlo, tra gli altri, il report Bridging the Generational AI Gap: Unlocking Productivity for All Generations, realizzato dalla London School of Economics in collaborazione con Protiviti. Secondo lo studio, l’adozione dell’AI permetterebbe ai lavoratori di recuperare in media sette ore e mezza a settimana da attività ripetitive e a basso valore aggiunto, mentre alle imprese consentirebbe di risparmiare fino a 18mila dollari all’anno per dipendente. L’impatto diventa ancora più significativo se all’uso della tecnologia si affianca un percorso di formazione mirato. In questo caso, il tempo risparmiato salirebbe fino a undici ore settimanali e il beneficio economico crescerebbe in proporzione.
L’AI funziona solo se trasforma il modo in cui si lavora. Le grandi ondate tecnologiche impiegano anni, a volte decenni, prima di tradursi in aumenti misurabili di produttività: è successo con l’elettricità e, più di recente, con computer e Internet. E qualcosa di simile sta succedendo di nuovo con l’AI. Se si usa una tecnologia nuova per replicare vecchi processi, si ottengono solo guadagni marginali. Automatizzare un flusso inefficiente lo rende semplicemente più veloce nel produrre inefficienza. L’AI sprigiona il suo potenziale quando ridisegna i processi, riduce o elimina passaggi intermedi inutili, sposta il lavoro umano verso decisioni, giudizio, creatività, modificando ruoli, responsabilità e metriche di performance.
La tecnologia inoltre funziona solo se è accompagnata da nuove competenze e nuove forme di organizzazione del lavoro. Se la produttività è prima di tutto un fatto organizzativo, l’AI può aiutare a ridurre i livelli gerarchici inutili, accorciare le catene decisionali, rendere l’informazione accessibile a chi crea valore. Altrimenti rischia di diventare un costo aggiuntivo, non un moltiplicatore. Non si può ridurre l’AI a un semplice strumento: è qualcosa di più, e soprattutto di diverso. Qualcuno l’ha definita un “lavoratore cognitivo” che affianca l’essere umano. Realisticamente, l’AI può aumentare il valore per ora lavorata, ridurre il lavoro ripetitivo, migliorare la qualità delle decisioni, valorizzare competenze già presenti. Non può compensare carenze strutturali di capitale umano né supplire a riforme organizzative o creare produttività dove manca una strategia. Come ha scritto il Nobel per l’economia Joseph Stiglitz, la tecnologia non determina il destino economico di un paese. Solo le istituzioni e le scelte collettive possono farlo.