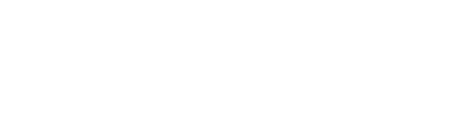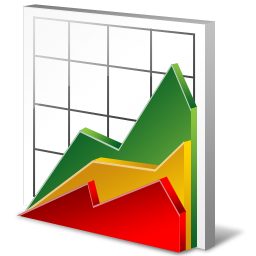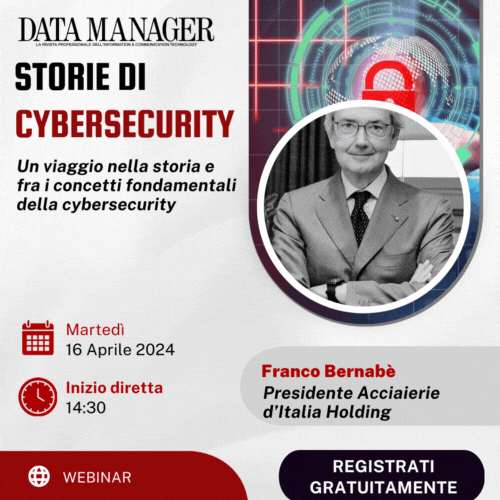Nell’era della digital transformation, ricorrere a soluzioni software defined di estrazione open source può rivelarsi la mossa vincente, soprattutto in termini di rapido ritorno sull’investimento
«Poste sempre più sotto pressione dalla trasformazione digitale, le infrastrutture IT sono ormai quasi organismi viventi, nei quali il software conta più dell’hardware», sintetizza Gianni Sambiasi, Country Manager Italy di Suse, commentando con Data Manager l’ascesa del paradigma “software defined”. Nell’anno in cui compie il suo primo quarto di secolo di vita, visto che è attiva dal 1992, Suse è sempre più un protagonista nel mondo dell’open source, in cui opera da sempre, con un occhio di riguardo verso le distribuzioni Linux, ambito nel quale ha costruito la propria fama e il proprio successo. Con risultati di rilievo: «Nella prima metà dell’anno fiscale terminato il 31 Ottobre scorso, il nostro fatturato è cresciuto del 23 per cento, e nell’arco degli ultimi due anni abbiamo raddoppiato il nostro organico a livello mondiale», esemplifica Sambiasi, aggiungendo che, pur non potendo rilasciare cifre precise in quanto la società fa parte di un gruppo quotato in Borsa, «l’Italia è stata la country che ha performato meglio di tutti gli altri Paesi nell’intero periodo dal 2011 al 2017», quest’ultimo inteso come anno finanziario, e che «non a caso, anche quest’anno stiamo assumendo persone».
Focus sull’open source
Tra i motivi degli ottimi risultati di Suse, vi è anche il fatto di aver sempre privilegiato la parte tecnica, con un engineering che cura lo sviluppo continuo delle soluzioni, rigorosamente open source. Oltre al “classico” Linux, con la nota piattaforma di base Suse Linux Enterprise, dalla quale nascono anche altri prodotti della società, da tempo lo sviluppo punta anche su altro, come per esempio l’area del cloud OpenStack, arricchita lo scorso anno con nuovi “pezzi” acquisiti da Hewlett Packard Enterprise, oppure gli ambienti di tipo software defined. È su questi ultimi che l’attenzione del mercato si è intensificata, in ragione degli indubbi vantaggi in termini di flessibilità e scalabilità. Per esempio in ambito storage, dove le aziende si stanno rendendo conto che i sistemi di storage tradizionali non sono adatti a fronteggiare il proliferare dei dati nell’epoca della digital transformation.
Rivedere l’approccio
Una ricerca realizzata recentemente da Suse in collaborazione con LoudHouse, che ha intervistato oltre 1.200 responsabili IT di una vasta gamma di settori in 11 Paesi, ha evidenziato che solo il 6 per cento delle aziende ha già adottato soluzioni di tipo software defined in ambito storage, nonostante il 97 per cento degli intervistati abbia mostrato un forte interesse per questo tipo di soluzioni. «Queste percentuali dimostrano in sostanza che il mercato fa tuttora resistenza, anche se si rende conto di dover rivedere il proprio approccio», commenta Sambiasi, spiegando che «nella piramide dei dati, dove in cima vi sono quelli più critici e che rimangono sempre appannaggio dello storage tradizionale in quanto vi si accede costantemente, bisogna oggi guardare alla parte più ampia della piramide, formata dai dati di archivio oppure da quelli non strutturati, ai quali non si accede così spesso, ma che soprattutto crescono oggi a un tasso più elevato del tasso di decrescita dei costi dello storage tradizionale». Ecco perché, nell’era della digital transformation, diventa «pressante rivedere l’approccio allo storage: in primo luogo il suo costo, e a seguire la scalabilità e le prestazioni», sottolinea Sambiasi.
Il ROI in primo piano
La soluzione? Ricorrere al software defined storage, che disaccoppia le logiche di archiviazione dall’hardware sul quale vengono memorizzati i dati. E se la piattaforma scelta è di tipo open source, ancora meglio. «Le soluzioni tradizionali sono nove volte più costose della nostra piattaforma Suse Enterprise Storage, che è sul mercato da due anni e si arricchisce continuamente di funzionalità in grado di soddisfare tutte le esigenze», spiega Sambiasi. Come spiegare allora il basso tasso di adozione evidenziato anche dalla ricerca? «Storicamente, in Italia c’è sempre stata questa scarsa propensione ad adottare il nuovo, anche se negli ultimi tempi si è un po’ mitigata. Il vero ostacolo rimane la non diffusa conoscenza del modello open source: chi ha adottato Linux non ha alcun pregiudizio, ma gli altri tendono ad andare verso il vendor tradizionale», fa notare Sambiasi. Ma l’evoluzione si preannuncia positiva: «Valutando una scelta tecnologica, oggi non si parla quasi più di TCO, total cost of ownership, ma si privilegia il ROI, per capire in quanto tempo l’investimento si ripagherà. E dato che la nostra soluzione è flessibile, costa il giusto e soprattutto può vantare un ottimo ROI, quando il focus sarà tutto spostato su quest’ultimo aspetto, allora la strada sarà tutta in discesa. E questo avverrà presto», conclude Gianni Sambiasi.