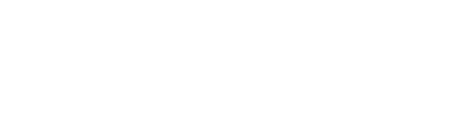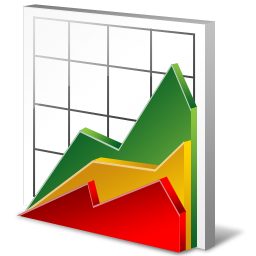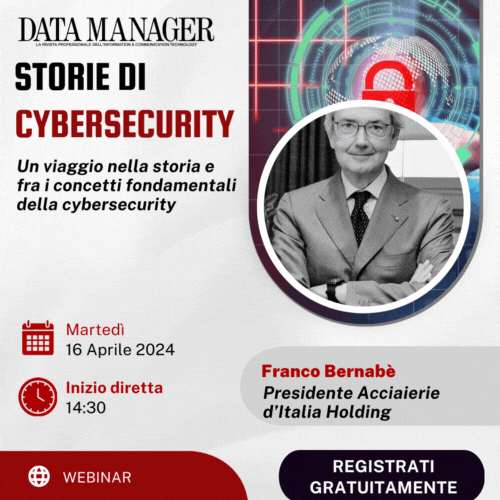A un certo punto della lunga dichiarazione pubblicata dal fondatore di Telegram Pavel Durov il 6 settembre scorso, a circa due settimane dal suo clamoroso arresto in Francia, si legge un passaggio molto eloquente.
Dalla fine di agosto, il caso Durov è al centro di un acceso dibattito ancora una volta centrato sui temi della libertà di espressione, del diritto alla privacy e del ruolo che la crittografia può avere in entrambi i domini. Fatta sempre salva la necessità di salvaguardare, assieme ai diritti, il dovere del rispetto della legalità.
«Using laws from the pre-smartphone era to charge a CEO with crimes committed by third parties on the platform he manages is a misguided approach». È fuorviante – scrive Durov – basarsi sulle leggi di un’epoca che precede l’invenzione dello smartphone, per accusare un CEO, un imprenditore, di un crimine commesso da una terza parte sulla piattaforma che quell’imprenditore gestisce.
In questa frase, c’è tutta la difficoltà di conciliare i tempi accelerati, addirittura frenetici dello sviluppo tecnologico, con il passo infinitamente più lento e riflessivo del sistema di regole e istituzioni che chiamiamo diritto. Il mancato allineamento tra le due scale temporali, reso ancora più drammatico dalla digitalizzazione di una realtà sempre più caratterizzata da elementi “software-defined”, ha già provocato parecchi guai. Anche quantificabili in termini economici se prendiamo fenomeni come la pirateria delle opere di ingegno non più vincolate alla distribuzione su supporti fisici (la carta, la pellicola) oppure a occasioni ben circoscritte e – come si direbbe oggi – “in presenza”.
A volte questo divario viene inutilmente accentuato. La legge, a pensarci bene, è abituata da sempre a distinguere tra intenzionalità e neutralità quando si tratta di giudicare un’azione, un delitto, perpetrato con l’aiuto di persone terze e o strumenti materiali. Se è vero che l’ignoranza della legge non è di per sé assolutoria, nessuno si sognerebbe di portare in tribunale il costruttore di un telefonino perché un dispositivo di quella marca è stato utilizzato per assoldare un killer.
Ma nel caso Durov, i margini di incertezza abbondano perché intorno alla piattaforma Telegram si dipanano mille implicazioni di natura politica. Avrebbe senso, poniamo, indebolirne la robustezza algoritmica e rischiare così di compromettere la possibilità di servire cause sacrosante come la corretta informazione, la lotta non-violenta contro regimi oppressivi, la riservatezza di transazioni finanziarie e commerciali del tutto autorizzate e così via?
Il dibattito non riguarda solo il modo di interpretare, applicare o aggiornare una regola, bensì il concetto stesso di regolamentazione. Davanti agli indubbi miglioramenti che la tecnologia sta portando in tutti i campi, è forte la tentazione di lasciare spazio se non alla più totale “deregulation”, a meccanismi di auto-regolamentazione che possano almeno aiutare a liberarci, dalle difficoltà di adattamento tra diversi contesti. Del resto, si spreca molto inchiostro anche per mettere in debita evidenza le due diverse culture, americana ed europea, in materie come la burocrazia, la privacy, la libertà di impresa.
Tutti gli sforzi dovrebbero andare in direzione del dialogo e del confronto, non delle generalizzazioni o degli estremismi. La crittografia non rende automaticamente Durov un fiancheggiatore o, viceversa, la bandiera di chi resiste alle dittature: si deve sempre giudicare, con gli strumenti giuridici di cui disponiamo ma su casi specifici, sulla base di argomentazioni solide e di esempi concreti. Continuando a perseguire l’obiettivo di una felice convivenza tra codici finalmente capaci di venirsi incontro.