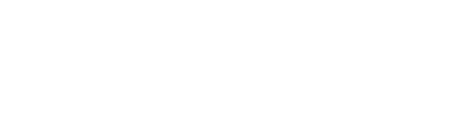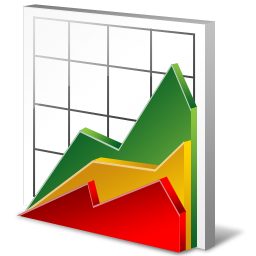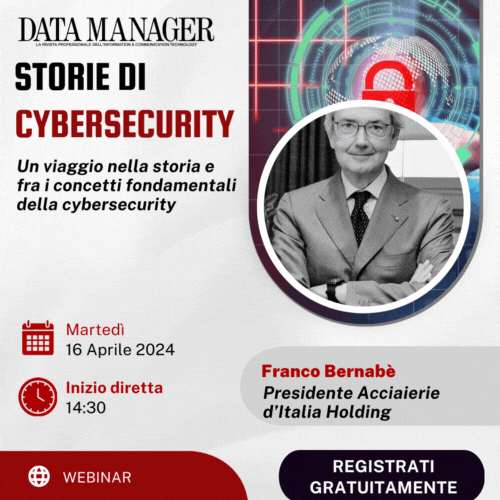Fiducia o codice? L’adozione sbagliata dell’intelligenza artificiale rischia di essere solo un “lifting costoso”. L’Italia? Un hub avanzato di sperimentazione AI, specie nel settore bancario, grazie a un approccio pragmatico e centrato sul valore di business
L’intelligenza artificiale è la regina indiscussa di convegni, keynote e tavole rotonde. La si invoca come panacea e si discute di modelli predittivi, etica computazionale e futuri post-umani con una naturalezza che rasenta, a volte, la mistificazione. Ma in mezzo al rumore di fondo dell’hype e della retorica tecnologica, pochi osano dire quello che Bob Messier, senior vice president Global Technology Services di SAS afferma con sincerità disarmante: «Modernizing for modernizing’s sake doesn’t always achieve the business outcome you want». Spendere denaro per progetti AI dal dubbio futuro solo per dire di averlo fatto è il modo più costoso per non cambiare nulla. Lo abbiamo incontrato durante la tappa italiana di SAS Innovate on Tour 2025.
L’AI, questa sconosciuta?
«Una delle difficoltà principali sia con i clienti che internamente alle organizzazioni, è accordarsi su cosa intendiamo davvero per intelligenza artificiale» – spiega Messier, con tono pacato ma affilato. «Alcuni pensano che si tratti di un report generato sulla base di regole predefinite. Altri la confondono con l’analisi descrittiva». Una confusione semantica che porta a scelte sbagliate. Per SAS, l’intelligenza artificiale è un insieme di discipline – computer vision, machine learning – da usare solo quando servono davvero e non un’etichetta da appiccicare su ogni processo automatizzato. «Per noi, quelle sono le vere frontiere dell’AI. Ecco perché è fondamentale assicurarsi che tutti – clienti, partner, sviluppatori – abbiano una comprensione condivisa di opportunità e limiti dell’AI» – continua Messier, che di trasformazione in quasi trent’anni di attività, ne ha viste e guidate parecchie. Prima nei sistemi finanziari e oggi ai vertici di SAS.
Ma sempre impegnato a far dialogare modelli matematici, compliance e business insieme. «Troppi progetti partono dall’idea di usare l’AI a tutti i costi, come se bastasse invocarla per risolvere qualsiasi inefficienza. Invece, bisogna partire da un business case misurabile, e costruire intorno a questo un progetto snello, capace di generare risultati tangibili nel breve termine». Un approccio quasi “artigianale” nel senso migliore del termine. Poca ideologia, molta concretezza. Invece di bruciare budget in sperimentazioni fumose, Messier propone una metrica semplice: Funziona? Genera valore? È sostenibile? E se la risposta è no, forse non serve un modello AI, ma tornare a farsi le domande giuste. Una lezione di realismo che molte aziende, ancora oggi, faticano a metabolizzare.
Modello giusto, cultura sbagliata
Nel mondo ideale dell’AI, tutto è fluido, ottimizzato, scalabile. In realtà – racconta Messier – le cose vanno diversamente. «Molte aziende trasferiscono codice legacy nel cloud senza nemmeno adattarlo. Così facendo, però, non si sfruttano appieno né le potenzialità dell’infrastruttura né i nuovi modelli di distribuzione delle applicazioni. In molti casi, ci ritroviamo a spiegare che esistono approcci più efficienti ed economicamente più vantaggiosi. Si tratta di un equilibrio delicato: non possiamo imporre soluzioni, possiamo solo accompagnare». È un nodo che va oltre l’IT. Legato a doppio filo con la resistenza al cambiamento e al tempo stesso con la tendenza, molto diffusa, di trattare l’AI come uno slogan più che come uno strumento.
Interoperabilità e sicurezza
In un mercato che si sta rapidamente popolando di nuovi competitor, con le soluzioni open source a fare da grimaldello, SAS ha scelto di aprire la propria piattaforma, senza rinunciare alla propria identità. «Con SAS Viya abbiamo adottato un’architettura aperta, basata su API, che dialoga con Azure, Google, Python, e così via. Con Workbench offriamo un ambiente ideale per sviluppare sfruttando la capacità di calcolo SAS». La strategia è di abbracciare il mondo open source senza sacrificare la precisione ingegneristica. E intanto, continuare a distinguersi: nel risk management, nella lotta antifrode, nella modellazione predittiva dei comportamenti. «Sviluppiamo applicazioni per rischio e frode da oltre vent’anni. E questo costituisce un nostro tratto distintivo importante» – sottolinea Messier.
Risultato, interoperabilità reale, ma infrastruttura che resta solida. Una risposta alla complessità crescente di ambienti multicloud, dati distribuiti e regolamenti divergenti. «I nostri clienti chiedono flessibilità e garanzie. Noi offriamo entrambe». L’AI, si sa, può produrre risultati inattesi. Ma a volte il problema non è l’output, quanto l’incapacità di accettarlo. «Costruiamo modelli che dimostrano l’irrilevanza di talune metriche sull’utile operativo. Questo in alcuni casi spiazza il cliente. Che magari ha gestito l’azienda per vent’anni utilizzandole ripetutamente» – racconta Messier con un mezzo sorriso. Da qui, la necessità di educare il management, non solo l’IT. «Con gli executive parliamo di implicazioni strategiche. Con gli user, invece, offriamo ambienti di test con dati fittizi, per imparare a usare il software senza rischi».
Prevenire i bias potenziali
Parlare di AI oggi, significa anche parlare di etica. Da quattro anni, SAS ha creato una data ethics practice, guidata da Reggie Townsend. Il focus? Prevenire danni invisibili. «Abbiamo individuato 31 tipi di bias potenziali nei modelli. Li intercettiamo già nella fase di ingestion dei dati. Continuiamo a lavorare affinché gli strumenti di interpretabilità e alert inseriti nel software siano sempre aggiornati. E per rendere il tutto verificabile e trasparente direttamente sulla piattaforma» – spiega Messier. «Con un clic, il cliente “vede” l’intero processo. Chi ha costruito il modello, con quali algoritmi e variabili. Uno strumento utile per i regolatori, ma soprattutto per la trasparenza interna».
Ma perché l’adozione dell’AI stenta, anche dove la tecnologia è matura? La resistenza prima che tecnica è culturale. «A volte l’AI contraddice decenni di decisioni prese in base a pratiche consolidate. Se l’algoritmo ti dice che le metriche su cui hai sempre basato la tua strategia non servono a nulla, il problema non è il codice. È la fiducia».
Italia, laboratorio avanzato
SAS opera in Italia da quasi 40 anni. E il rapporto con le grandi banche italiane, ha creato un ecosistema tecnico-culturale d’élite. «I clienti italiani, specie nel settore bancario, sono tra i più sofisticati. Alcuni erano pionieri degli analytics già vent’anni fa: il passaggio all’AI per loro è stato naturale». In SAS circola una frase che la dice lunga: “Guardiamo cosa stanno facendo in Italia”. «È vero, l’Italia non è il nostro mercato più grande ma di certo è uno di quelli che detta il passo. Alcuni dei nostri migliori use case arrivano da qui» – racconta Messier. Merito di tanti fattori – dalla preparazione alla pressione normativa – ma anche di una capacità critica tutta italiana. Quella di non adottare una tecnologia solo perché è di moda. Messaggio condiviso da Messier che rilancia: «Si adotta quando serve e se serve davvero. Quando non danneggia, non mente e non discrimina».