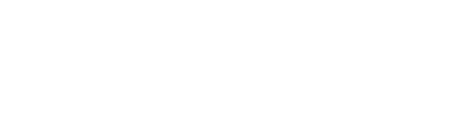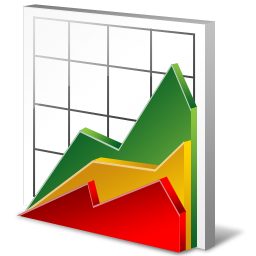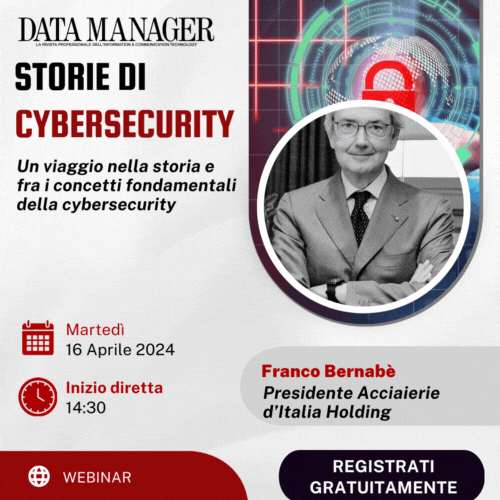Automazione, intelligenza artificiale e gestione integrata dell’energia trasformano l’industria delle costruzioni in un ecosistema in grado di generare valore, prevedere guasti e proteggere la sicurezza di persone e impianti, riducendo fino al 40% i costi operativi
Gli edifici “intelligenti” che sfruttano le tecnologie digitali e le applicazioni dell’Internet of Things (IoT) per rendere più sostenibili e confortevoli gli ambienti e per ottimizzare sicurezza ed efficienza sono più di una tendenza. Vari studi etichettano gli smart building come uno dei principali fattori di cambiamento per gli anni a venire, sotto la spinta anche dalla nuova normativa ambientale. Alcuni dati di prospettiva rimarcano l’attendibilità di questa visione. Città sempre più grandi, reti sempre più affamate di energia: entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane e i consumi elettrici globali saranno il doppio di quelli attuali (dati MASE). Secondo diversi analisti, il prossimo decennio sarà caratterizzato da tre tendenze: aumento significativo della produzione e dell’impiego di energie rinnovabili, forte espansione del mercato globale delle smart infrastructure e crescita a doppia cifra della domanda di infrastrutture per la mobilità elettrica, l’accumulo e la distribuzione intelligente dell’energia.
ECOSISTEMA IN CRESCITA
I dati disponibili sono limitati per fotografare in modo adeguato e preciso le dimensioni del mercato italiano dello smart building, ma uno studio della Community Smart Building di The European House – Ambrosetti (TEHA) che risale alla scorsa primavera, permette di avere un quadro indicativo della situazione e delle criticità che ancora permangono. Il comparto rappresenta un asset strategico sia per la competitività dell’Italia che per il raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica fissati dall’Unione Europea.
Ma nonostante la fase di espansione, è ostacolato da un evidente squilibrio tra la domanda e l’offerta di competenze dedicate. L’analisi fotografa un ecosistema che vale circa 174 miliardi di euro di fatturato e 38 miliardi di valore aggiunto, con 515mila addetti occupati lungo la filiera estesa e la possibilità di creare entro il 2030 ulteriori 200mila nuovi posti di lavoro qualificati, destinati a figure quali ingegneri, progettisti, installatori, tecnici specializzati e addetti alle vendite. Per contro, le imprese devono affrontare nell’immediato il problema di trovare i profili di cui hanno bisogno: l’84% delle posizioni aperte in questo settore richiede competenze green e smart, ma nel 58% dei casi non esistono candidati adeguati. Si tratta di un mismatch strutturale che affonda le radici in un tessuto occupazionale con livelli di istruzione mediamente bassi e un’età più alta rispetto alla media nazionale (solo il 13% degli occupati nel comparto possiede una laurea e il 62% ha tra i 35 e i 54 anni), che rende urgente un salto di qualità nella formazione tecnica, nella cultura digitale e nella capacità di integrazione tra sistemi, dati e impianti.
L’accelerazione verso la decarbonizzazione e l’efficienza energetica degli edifici è destinata comunque a ridefinire, in Italia come in tutta Europa, i paradigmi costruttivi e gestionali. Anche il nostro Paese dovrà infatti recepire entro due anni la nuova Direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD IV), che impone obiettivi stringenti di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica, e in tale scenario, la diffusione degli smart building diventa un asset strategico non solo per la sostenibilità ambientale, ma anche per la competitività industriale. La prospettiva è quella di una filiera capace di generare valore economico e sociale, creando occupazione qualificata in ambiti chiave dell’edilizia e dell’impiantistica avanzata. L’analisi di Ambrosetti, in tal senso, quantifica in 124mila gli operatori specializzati che serviranno a sostenere questo sviluppo, a cui si aggiungono 54mila installatori di sistemi evoluti (sistemi di climatizzazione e ventilazione, domotica, automazione, fotovoltaico), 14mila tecnici esperti in manutenzione, cybersecurity e integrazione di sistemi, 11mila fra ingegneri (elettronici ed energetici in primis) e sviluppatori software e, nondimeno, 10mila tra architetti, geometri e designer d’interni.
L’evoluzione dell’industria delle costruzioni impone una riconversione professionale su larga scala e percorsi di formazione continua e di aggiornamento tecnico per garantire il ricambio generazionale e mantenere la competitività delle imprese. La filiera degli smart building, proprio per la sua trasversalità, si configura infatti come un laboratorio avanzato dell’industria 5.0, dove la tecnologia incontra il capitale umano, e sono diverse le aziende che stanno già investendo in programmi di formazione on-the-job, in collaborazione con università e centri di ricerca (ne sono un esempio proprio le imprese partner della Community Smart Building di THEA, che coinvolgono ogni anno oltre 25mila professionisti in percorsi dedicati all’efficientamento energetico e all’uso evoluto delle soluzioni di automazione). Il futuro degli smart building e della filiera degli edifici intelligenti dipenderà quindi dalla capacità del sistema Paese di investire in risorse qualificate perché l’innovazione tecnologica alimentata dai sensori, dall’applicazione dell’intelligenza artificiale e dall’adozione di avanzati sistemi di gestione energetica non può prescindere da un tessuto di competenze aggiornate e integrate.
PIATTAFORMA DI SERVIZI
Gli edifici intelligenti portano in dote servizi molto diversi da quelli disponibili oggi. Dispositivi hardware e software di nuova generazione, il cloud e l’intelligenza artificiale traghetteranno gli “smart building” verso nuovi livelli, spostando l’attenzione dagli asset materiali verso servizi basati sull’esperienza di utilizzo degli spazi e sulla trasformazione delle strutture in centri di valore. L’interpretazione dei dati raccolti dai sensori, infatti, permetterà di adattare gli ambienti alle necessità di chi li vive, mentre la connessione degli edifici a micro-reti che ottimizzano il fabbisogno di energia in tempo reale (e in funzione delle fonti di alimentazione e dei carichi) abiliteranno modelli di business innovativi e finora inesplorati dalle pratiche di facility management tradizionale. Anche gli impianti, insomma, conosceranno il paradigma della “servitizzazione”: l’utente (azienda, ente o altro soggetto) passerà dal possedere il proprio sistema di illuminazione a un modello “pay-per-use”, grazie alla disponibilità di smart grid che faranno risparmiare energia e rivendere quella in eccesso. Rendere le infrastrutture di una città (ma non solo) più intelligenti significa quindi popolarla di edifici che consumano meno e che al contempo producono energia grazie a pannelli fotovoltaici installati sul tetto o integrati nelle facciate. Il potenziale di crescita di questo settore è enorme e, non a caso, sta spingendo giganti e startup tech a sviluppare soluzioni in grado di rendere i building veri e propri oggetti connessi, in grado di comunicare e scambiare dati con le reti elettriche, le infrastrutture del traffico o gli impianti di smaltimento dei rifiuti.
Federico Frattini e Laura Mercati, rispettivamente vicedirettore dell’Osservatorio Energy & Strategy e project manager dell’Energy Efficiency Report del Politecnico di Milano, hanno provato a delineare un quadro dettagliato di come sta evolvendo il panorama edilizio in Italia, partendo dal presupposto che gli immobili non sono più considerati semplici involucri, ma si trasformano in piattaforme capaci di integrare e ottimizzare sistemi energetici, digitali e di sicurezza fisica e digitale. Questa transizione verso gli “smart building”, spiegano i due esperti, coinvolge l’intero spettro di strutture (uffici, complessi industriali, spazi commerciali, edifici residenziali e pubblici) e ha come obiettivo primario l’efficienza energetica, il comfort degli occupanti e l’avanzamento della digitalizzazione. In tale contesto, i cosiddetti Building Automation and Control Systems (BACS), ovvero i sistemi preposti alla gestione automatizzata delle performance degli edifici, emergono come una delle leve più promettenti per il contenimento dei consumi, con risparmi energetici calcolabili nell’ordine del 20-25%. Questo potenziale è particolarmente rilevante nel comparto non residenziale dove – secondo l’Energy Efficiency Report 2025 – i tempi di rientro dell’investimento risultano assai vantaggiosi, attestandosi tra i tre e i quindici mesi in funzione della tipologia di edificio.
Nonostante il chiaro beneficio economico, la diffusione dei BACS in Italia è però ancora contenuta a causa di barriere prevalentemente di natura culturale, legate alla scarsa consapevolezza dei vantaggi generabili e a una carenza di competenze tecniche lungo la filiera della progettazione. Oggi negli edifici non residenziali è già obbligatorio installare tali sistemi di controllo per gli impianti termici con potenza superiore a 290 kW e questo può rappresentare un impulso significativo allo sviluppo del settore.
Parallelamente ai BACS, si osserva la crescente adozione degli Energy Management Systems (EMS): si tratta di piattaforme deputate al monitoraggio in tempo reale delle prestazioni energetiche di edifici o impianti produttivi e aventi il fine di ottimizzarne i consumi. In ottica prospettica – spiegano in proposito Frattini e Mercati – la direzione è verso EMS “intelligenti”, capaci cioè di integrare le funzioni tradizionali di controllo con analisi predittive e di scenario, rese possibili dall’applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning. Nell’ambito specifico dell’industria delle costruzioni, i Building Energy Management Systems (BEMS) rappresentano l’apice di questa logica: parliamo infatti di piattaforme più sofisticate, in grado di identificare e attuare automaticamente le azioni più efficaci per massimizzare l’efficienza energetica, mantenendo inalterati i livelli di comfort, sicurezza e salubrità per gli occupanti.
Il traguardo a cui fare riferimento nel breve termine, per capire l’effettivo impatto dei sistemi sopra descritti, sono gli obiettivi europei fissati per il 2030, il cui raggiungimento richiederà (sempre secondo l’ultima edizione del report), investimenti complessivi stimabili attorno ai 300 miliardi di euro per il miglioramento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio nazionale. Un dato che conferma non solo il grandissimo potenziale di questo mercato, ma anche la portata della sfida per la decarbonizzazione del settore. In Italia – secondo le stime di ENEA – il 31% degli edifici non residenziali e il 45% di quelli residenziali rientrano infatti nelle classi energetiche più inefficienti (F e G) e in un tale scenario l’adozione di BACS e BEMS (e in generale del più ampio paradigma dello smart building) assumono un ruolo strategico proprio perché strumenti essenziali per monitorare, regolare e ottimizzare i consumi, abbattere i costi operativi.
L’edificio “intelligente” – questa la conclusione dell’analisi a firma dei due esperti del Politecnico – non limita comunque la sua funzione all’efficienza dei consumi: l’integrazione sistemica tra l’infrastruttura energetica e i dispositivi di sicurezza fisica (apparecchi per il controllo degli accessi, telecamere di videosorveglianza, sistemi antincendio e di gestione delle emergenze) consente una risposta automatica e coordinata in caso di eventi critici. In ambienti come data center e stabilimenti industriali, in particolare, dove la continuità operativa è un fattore di resilienza aziendale, la building automation costituisce un elemento strutturale imprescindibile. La principale sfida per la piena realizzazione di questo modello risiede nell’interoperabilità dei sistemi, nella protezione dei dati gestiti e nella diffusione di competenze interdisciplinari lungo l’intera filiera. Solo superando questi ostacoli l’edificio potrà evolvere da semplice infrastruttura passiva a piattaforma attiva, capace di coniugare in modo sinergico efficienza energetica, funzionalità multipla, sicurezza integrata e dialogo con il tessuto urbano.
SMART & GREEN
Alla fine del 2019, l’Unione Europea ha lanciato il Green Deal, una strategia per conciliare la crescita economica con la sostenibilità ambientale. Al suo interno rientra un pacchetto di iniziative strategiche che dovranno guidare la transizione verde in tutti i settori, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Circa due anni dopo, è stato introdotto il pacchetto “Fit for 55%” che ha stabilito un obiettivo intermedio per il 2030, puntando a ridurre le emissioni interne di gas serra almeno del 55% rispetto ai livelli del 1990. Il settore delle costruzioni è ampiamente coinvolto in questa trasformazione radicale, considerando che proprio gli edifici sono responsabili del 40% del consumo di energia elettrica nella UE (e del 36% delle emissioni di gas serra associate all’energia) e che il 75 % è inefficiente sotto il profilo energetico.
In questo contesto è nata la quarta versione della direttiva EPBD IV, Energy Performance Building Directive (2024/1275), comunemente chiamata “direttiva case green”, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale l’8 maggio 2024. Contiene tutte le raccomandazioni per contribuire a raggiungere gli obiettivi del Green Deal nel settore dell’edilizia e gli Stati membri della UE dovranno recepirla entro la metà del prossimo anno con i rispettivi piani nazionali di ristrutturazione. Nondimeno, la direttiva è destinata ad avere un impatto significativo sullo sviluppo degli smart building, grazie al coinvolgimento diretto di sistemi di gestione evoluti (BACS e BEMS) che dovranno supportare la gestione efficiente e sostenibile del consumo e dell’autoproduzione di energia negli edifici. L’EPBD IV indica importanti obiettivi per il parco edilizio europeo, concentrandosi sia sugli edifici residenziali sia su quelli non residenziali; gli edifici nuovi (residenziali e non) entro il primo gennaio 2030 dovranno essere a “energia zero”, mentre tale termine è anticipato al 2028 per quelli di proprietà della pubblica amministrazione. Nel frattempo, tutti dovranno comunque essere a energia “quasi zero”, e cioè con consumi molto bassi e alimentati prevalentemente da fonti rinnovabili, presenti nell’edificio stesso o nelle vicinanze. Molto lavoro dovrà essere concentrato sugli edifici esistenti. Per centrare gli obiettivi della direttiva, infatti, ogni singolo paese dovrà ottenere il 55% del risparmio energetico tramite l’efficientamento del 43% del patrimonio edilizio esistente più energivoro. Se guardiamo all’Italia, qualcosa come cinque milioni di edifici dovranno essere riqualificati. Per il settore non residenziale, ogni paese dovrà stabilire un limite di prestazione energetica minima basato sulla situazione del patrimonio edilizio nazionale di aggiornato al 2020; ciascun piano di ristrutturazione dovrà assicurare nello specifico che il nuovo valore sia inferiore rispetto a quella soglia, e precisamente del 16% nel 2030 e del 26% nel 2033.
L’importanza data alle tecnologie “smart” dalla direttiva EPBD IV è confermata dai nuovi obblighi per l’integrazione di sistemi BACS nel settore non residenziale e, progressivamente, anche in quello residenziale. È utile precisare, in proposito, come questi sistemi siano già obbligatori da quest’anno negli edifici destinati a un uso professionale e industriale con impianti termici di potenza maggiore a 290 kW (come ha stabilito la EPBD III), ma con la direttiva “case green” tale l’obbligo sarà esteso anche agli edifici con impianti termici di potenza superiore a 70 kW a partire da gennaio 2030.
Per facilitare l’introduzione delle soluzioni BACS e BEMS, la direttiva prevede inoltre la creazione di un nuovo Smart Readiness Indicator, un indicatore comune a livello europeo (la cui definizione è prevista entro la metà del 2027) che permetterà di valutare l’intelligenza degli edifici. I sistemi BACS, lo ricordiamo, abilitano il monitoraggio e il controllo degli impianti tecnologici dell’edificio (riscaldamento, ventilazione e condizionamento, illuminazione, schermature solari, produzione di acqua calda sanitaria) con l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei consumi energetici e del comfort ambientale. Fra le peculiarità che li distinguono spicca la capacità di integrarsi con piattaforme centralizzate come i BMS (Building Management System) e i già citati BEMS per lavorare in piena sinergia in contesti complessi. In altre parole, i BEMS possono utilizzare i dati raccolti dai BACS per analizzare in profondità consumi e flussi energetici, individuando inefficienze e identificando azioni per ridurre gli sprechi.
Non è certo un caso che uno degli obiettivi della direttiva EPBD IV sia quello di promuovere l’adizione delle tecnologie di Building Automation and Control Systems più evolute (quelle di classe A), dato che possono apportare risparmi energetici anche superiori al 30%, rispetto ai sistemi privi di automazione. In particolare, la norma stabilisce che i BACS devono monitorare continuamente i consumi energetici, individuare eventuali inefficienze e inviare notifiche per possibili ottimizzazioni, interagire in modo interoperabile con altri sistemi e dispositivi tecnici e, a partire dal 2026, integrare il monitoraggio della qualità ambientale interna. Si sta viaggiando insomma molto velocemente verso uno scenario dove gli edifici, resi intelligenti da queste tecnologie, diventeranno piattaforme in grado di gestire in autonomia e in modo ottimizzato i consumi e l’auto-produzione, adattandosi dinamicamente alle condizioni interne ed esterne, interagendo con la rete elettrica e contribuendo alla sua stabilità. Per le aziende, la disponibilità di sistemi smart integrati negli edifici comporta una serie di vantaggi: automatizzare la raccolta e l’analisi dei dati, avendo una visione chiara dei consumi e dell’impatto ambientale, genera come primo risultato diretto un aumento dell’efficienza e una riduzione dei costi operativi per il fabbisogno energetico. Un secondo vantaggio, assolutamente non trascurabile, è legato alla possibilità di avere una rappresentazione precisa e puntuale del proprio impatto tramite report dettagliati, semplificando il monitoraggio dei KPI a supporto della conformità alle normative di rendicontazione in ambito CSDR e al rating ESG.
OLTRE L’EFFICIENZA ENERGETICA
Uno smart building, per definizione, è un edificio dotato di tecnologie intelligenti e integrate che permettono di gestire in modo automatizzato e ottimizzato energia, sicurezza, comfort e comunicazioni. Ma quali sono e come lavorano nel dettaglio queste tecnologie? In rapida successione, possiamo elencare i sensori connessi a un’architettura IoT che monitorano continuamente parametri come temperatura e umidità, permettendo di adattare l’uso dell’energia alle reali necessità di chi opera all’interno dell’edificio e di modulare i consumi in base alla disponibilità o ai prezzi dell’energia. Appositi software gestiscono in modo automatico e coordinato gli impianti di riscaldamento e illuminazione e controllano i sistemi sicurezza, mentre il ricorso a fonti rinnovabili tramite pannelli solari e batterie consente di produrre e immagazzinare energia localmente, riducendo così la dipendenza da fonti tradizionali. L’intelligenza artificiale, non in ultimo, entra in gioco per prevedere i consumi e ottimizzare il funzionamento dei vari sistemi.
Uno smart building – sia esso un headquarter aziendale, un impianto di produzione avanzato o un grande hub commerciale – non si limita come già detto ad aumentare il livello di efficienza energetica. La sua vera intelligenza risiede nell’integrazione sinergica di tutte le funzioni operative e di sicurezza: l’immobile, di fatto, si trasforma in un sistema nervoso digitale, essenziale non solo per la gestione dei costi, ma come pilastro della continuità operativa delle attività svolte al proprio interno. Il primo strato di intelligenza si manifesta nella fusione tra i sistemi di security (per la protezione da accessi non autorizzati e dalle minacce esterne) e quelli di safety (che operano per la sicurezza degli occupanti e la prevenzione di incidenti come incendi o guasti): questa sinergia crea un ambiente non solo più protetto, ma anche più resiliente e reattivo alle emergenze.
Il punto di partenza di questa integrazione è la convergenza dei sistemi di controllo degli accessi con le infrastrutture operative dell’edificio, e quindi i BMS. L’utilizzo di soluzioni di identificazione biometrica (riconoscimento facciale, impronte digitali o scansione dell’iride) non è più funzionale solo a sbloccare un tornello, ma diventa una fonte dati di primaria importanza per la gestione in tempo reale dei flussi del personale e dell’occupazione degli spazi. Quando, per fare un esempio concreto, un dipendente accede a un piano o a un’area riservata, il suo ingresso autenticato innesca una serie di automazioni intelligenti, a cominciare dalla regolazione dinamica del sistema di climatizzazione per ottimizzare il comfort solo in quell’area specifica, basandosi sulla densità effettiva di persone rilevata e riducendo allo stesso tempo gli sprechi nelle zone inattive. Studi condotti da Gartner e ABI Research evidenziano come questo modello di gestione granulare, basato sull’identità e sul posizionamento in tempo reale tramite tecnologie di Indoor Positioning System, può portare a una riduzione dei costi operativi superiori al 15% in grandi complessi, migliorando parallelamente la user experience e il benessere degli occupanti.
Le efficienze generate da un Building Management System (BMS) derivano dalla sua capacità di agire come un vero e proprio “cervello operativo” dell’edificio. Il sistema monitora in tempo reale migliaia di parametri, dai consumi energetici alle temperature, fino allo stato di funzionamento delle apparecchiature critiche, come caldaie, pompe o unità di ventilazione. Questo monitoraggio continuo consente di anticipare potenziali problemi prima che si manifestino, attraverso i cosiddetti “alert predittivi”. Per esempio, se un motore di un impianto mostra segnali di surriscaldamento anomalo o un comportamento fuori standard, il BMS può intervenire automaticamente: deviare il carico su un sistema di backup, ridurre temporaneamente l’attività dell’apparecchio, oppure avviare procedure di manutenzione preventiva, anche da remoto.
Secondo le stime dell’International Facility Management Association (IFMA), gli edifici che implementano strategie di microgrid (piccole reti energetiche gestite autonomamente), sistemi di accumulo e BMS avanzati possono ridurre l’impatto finanziario e operativo di un’interruzione di corrente di oltre il 40%.
PROGETTAZIONE E RESILIENZA
Secondo gli analisti di MarketsandMarkets, l’implementazione di sistemi di sicurezza e antincendio con AI integrata sta crescendo rapidamente, grazie al drastico taglio dei tempi di reazione e alla capacità di trasformare la risposta all’emergenza in un processo orchestrato e guidato digitalmente. Il vero salto di qualità avviene quando i dati generati da questi sistemi ed elaborati dagli algoritmi interagiscono direttamente con i sistemi di safety: le telecamere ad alta definizione non operano come semplici occhi elettronici, ma si trasformano in sensori attivi in grado di eseguire analisi complesse in tempo reale, identificando anomalie comportamentali (come assembramenti improvvisi) o l’abbandono di oggetti sospetti. Per le attività di business che dipendono dalla costante disponibilità delle proprie infrastrutture (fabbriche, laboratori, uffici), la resilienza del building è un fattore non più negoziabile, proprio perché l’edificio è integrato nella strategia di gestione del rischio aziendale e ne segna di fatto l’evoluzione.
Il modello di riferimento è rappresentato dai data center, strutture concepite per operare con livelli di uptime che raggiungono il 99,999% e i cui principi di ridondanza e tolleranza ai guasti vengono estesi all’intera infrastruttura aziendale. Componente chiave negli edifici intelligenti, tanto quanto i sistemi BACS e BEMS, è la progettazione digitale: un passaggio a monte che definisce l’efficacia dell’intera infrastruttura. A sottolinearne l’importanza è Riccardo Pagani, consigliere con delega all’Innovazione e alle nuove tecnologie di IBIMI buildingSMART Italia. «L’evoluzione degli edifici intelligenti – spiega l’esperto – passa dalla capacità di integrare informazioni, modelli e tecnologie lungo l’intero ciclo di vita dell’opera. La progettazione diventa in tal senso un processo dinamico in cui dati, algoritmi e simulazioni guidano le decisioni fin dalle prime fasi di ideazione. L’intelligenza artificiale applicata al digital twin, per esempio, consente di prevedere comportamenti energetici, ottimizzare i materiali, ridurre costi e tempi, creando le condizioni per progettare edifici realmente sostenibili e adattivi».
Il settore delle costruzioni – come evidenzia ancora Pagani – sta vivendo una trasformazione senza precedenti, passando da industria tradizionale a ecosistema digitale, dove progettazione, produzione e gestione convergono grazie all’utilizzo dei dati. «Affinché questo principio si concretizzi servono però interoperabilità e linguaggi condivisi» – avverte Pagani. Gli standard openBIM (di cui IBIMI è il punto di riferimento per la loro applicazione in Italia) rappresentano il fondamento su cui costruire l’ecosistema tecnologico dello smart building, sfruttando formati aperti e regole comuni per far dialogare software, sensori IoT e sistemi di automazione in modo coerente, trasparente e scalabile. Se il settore delle costruzioni, sta diventando un ecosistema digitale, «la vera innovazione – conclude Pagani – nasce dalla capacità di condividere informazioni, adottare standard comuni e costruire un linguaggio che connette persone, processi e sostenibilità».
Le soluzioni Brother a supporto degli smart building