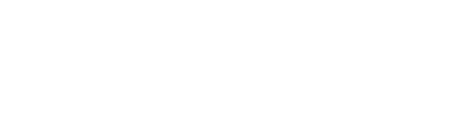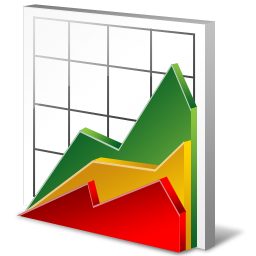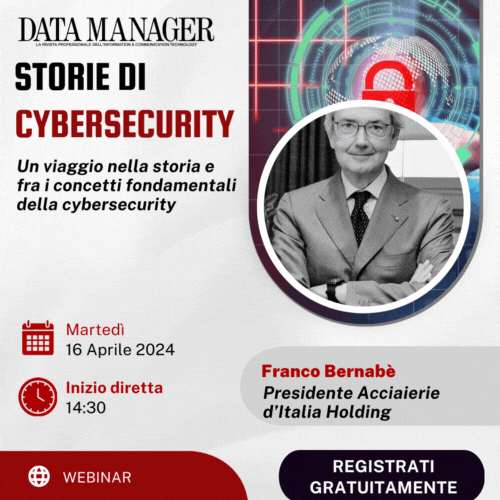Non si parla di corda in casa dell’impiccato. Tuttavia, di fronte al prolungarsi della serie dei numeri in rosso del settore ICT, numeri che indicano che il consumo “reale” cresce, ma a una velocità inferiore a quella con cui calano i prezzi, ci si può chiedere: «Perché la domanda dovrebbe crescere»? Se le grandi imprese italiane – dove è maggiormente concentrata l’innovazione e la capacità di marketing – contano sempre meno nel mondo, chi dovrebbe investire? Molte delle aspettative si sono indirizzate verso il settore pubblico, più per spingere i comportamenti dei privati che per incrementare la dotazione tecnologica, ma siamo sicuri che sia stata presa la giusta direzione? Le pressioni delle lobby per aumentare la domanda digitale rischiano di partorire i classici topolini ciechi, puntando l’attenzione sulla inutile pagliuzza al posto della trave fondamentale. Gli esempi non mancano. Della Pec non si sa ancora bene che cosa fare, del Cud digitale per i pensionati sono state riempite pagine di giornali. Le iscrizioni online a scuola, dopo i primi giorni di overflow dei server, alla fine sono andate bene (due terzi l’hanno fatta da casa o dall’ufficio), ma ci hanno guadagnato più le segreterie delle scuole – che in fondo sono pagate per quello – che gli utenti. Dove sta il vantaggio? Al MIUR, il ministro Profumo (dimissionario, ma ancora in carica al momento in cui scriviamo) ha concentrato le sue attenzioni sulla digitalizzazione della scuola, accelerando il “time table” dell’e-book. Non vi sono per ora riscontri reali, nazionali o internazionali, dell’utilità didattica del passaggio dalla carta e dall’inchiostro al display e alle batterie dei tablet.
Non si parla di corda in casa dell’impiccato. Tuttavia, di fronte al prolungarsi della serie dei numeri in rosso del settore ICT, numeri che indicano che il consumo “reale” cresce, ma a una velocità inferiore a quella con cui calano i prezzi, ci si può chiedere: «Perché la domanda dovrebbe crescere»? Se le grandi imprese italiane – dove è maggiormente concentrata l’innovazione e la capacità di marketing – contano sempre meno nel mondo, chi dovrebbe investire? Molte delle aspettative si sono indirizzate verso il settore pubblico, più per spingere i comportamenti dei privati che per incrementare la dotazione tecnologica, ma siamo sicuri che sia stata presa la giusta direzione? Le pressioni delle lobby per aumentare la domanda digitale rischiano di partorire i classici topolini ciechi, puntando l’attenzione sulla inutile pagliuzza al posto della trave fondamentale. Gli esempi non mancano. Della Pec non si sa ancora bene che cosa fare, del Cud digitale per i pensionati sono state riempite pagine di giornali. Le iscrizioni online a scuola, dopo i primi giorni di overflow dei server, alla fine sono andate bene (due terzi l’hanno fatta da casa o dall’ufficio), ma ci hanno guadagnato più le segreterie delle scuole – che in fondo sono pagate per quello – che gli utenti. Dove sta il vantaggio? Al MIUR, il ministro Profumo (dimissionario, ma ancora in carica al momento in cui scriviamo) ha concentrato le sue attenzioni sulla digitalizzazione della scuola, accelerando il “time table” dell’e-book. Non vi sono per ora riscontri reali, nazionali o internazionali, dell’utilità didattica del passaggio dalla carta e dall’inchiostro al display e alle batterie dei tablet.
In compenso, vi sono molti dubbi sul modo in cui finanziarne l’acquisto (perché si fa in fretta a dire che “provvederanno le scuole”), sui formati da adottare, sull’effetto dirompente sulla filiera dell’editoria di un mercato di e-book di seconda mano, ma venduti a pochi centesimi “come nuovi”. In altre direzioni dovrebbero indirizzarsi le priorità. A cominciare dai conti pubblici. Diceva qualche anno fa l’allora ministro all’innovazione Lucio Stanca, intervistato da Data Manager (lasciò un ricordo migliore in quella veste che in quella alla guida della barca dell’Expo): «In Italia, le ASL usano 63 codici diversi per indicare l’Aspirina. È fondato il sospetto che sia un ottimo sistema per impedirci di sapere quanta effettivamente se ne consuma». In queste settimane, si sta consumando un “pillolone” ben peggiore. Al di là della decisione governativa di “immettere” 40 miliardi di euro nel biennio per accelerare i pagamenti alle aziende, chi sa realmente quanti sono i debiti che la PA deve saldare? Sono 70, 90, 130, 150 miliardi? Il ministro dell’economia Grilli ammette: «Non lo sappiamo».
Quale perimetro adottare? Quanto è il debito complessivo? Quanto è scaduto e quanto scadrà nei prossimi mesi? Se a questo aggiungiamo che i soggetti di spesa sono decine di migliaia e che le casse statali dovrebbero essere in grado di erogare o “compensare” le risorse necessarie a questi enti che – a loro volta – dovranno pagare i fornitori, c’è da star freschi. «Non sono noccioline» – avrebbe potuto dire Pierluigi Bersani – ma il problema è evidente: non esiste un consolidato della PA che consenta di vedere i flussi e gli stock, di proiettare come su un maxi “scacchiere Excel” le fatture scadute e quelle che scadranno. Per il 30 settembre, è previsto un censimento dei pagamenti dovuti. Facile immaginare come andrà, ma soprattutto poteva essere un’occasione per adottare almeno formati comuni e compatibili. E se non è decollato il federalismo fiscale, di quello informatico – con il suo moltiplicarsi di data center, sistemi incompatibili, dati frammentari – forse ce n’è fin troppo. Qualcuno vuol metterci mano?