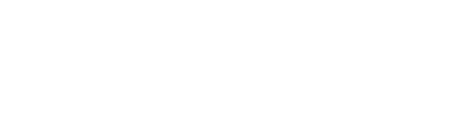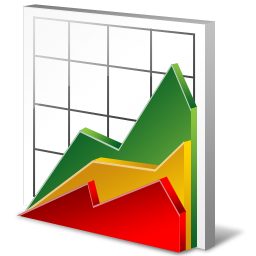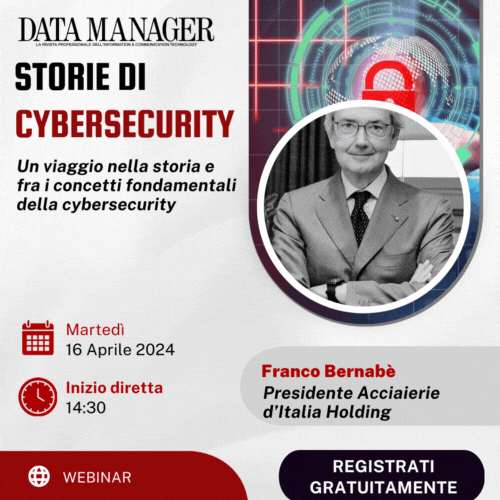L’adozione dell’AI nel sistema agroalimentare accelera innovazione e competitività. Produzione intelligente, tracciabilità, tutela del marchio, logistica integrata e interoperabilità dei dati diventano asset chiave per superare le criticità strutturali
L’agroindustria ha affrontato una vera e propria prova di resilienza dentro e fuori i confini UE, aggravata da tensioni geopolitiche e cambiamento climatico: prima l’esplosione dei costi energetici, poi l’impennata delle materie prime e infine l’impatto dei dazi. Eppure, il settore non solo ha retto l’impatto, ma ha reagito rilanciando in termini di innovazione. Le aziende italiane sono prime in Europa per esportazioni e valore aggiunto. A trainare la ripresa è la tecnologia, con l’intelligenza artificiale che assume un ruolo sempre più centrale in progetti strategici, dalla gestione predittiva delle colture all’automazione dei processi industriali. Un vero cambio di paradigma, che concentra l’attenzione su efficienza operativa, completa tracciabilità delle filiere, pianificazione dinamica della supply chain e approccio sostenibile all’intera produzione.
Il comparto agrifood sta adottando un articolato mix di strategie: dall’autoproduzione di energia al miglioramento dell’efficienza nei processi, dalla diversificazione dei mercati di sbocco alla tutela della biodiversità, fino allo sviluppo di pratiche di economia circolare. A questi si aggiungono ingenti investimenti sia nelle attività primarie sia nelle tecnologie, in particolare nel digitale e nell’intelligenza artificiale, per rafforzare la resilienza necessaria. Nonostante le previsioni in chiaroscuro, gli analisti confermano un outlook positivo anche per il 2025, sostenuto principalmente dalla domanda interna.
Tuttavia, si tratta di una realtà a doppia velocità: mentre l’industria alimentare registra anni da record, le imprese agricole crescono a un ritmo più contenuto, pur restando sopra la media dei principali Paesi europei. Secondo il report ISTAT di gennaio, nel 2024 il settore agricolo ha visto un aumento dell’1,4% nei volumi prodotti e una crescita dello 0,8% nei prezzi di vendita. Di conseguenza, il valore complessivo della produzione agricola a prezzi correnti è salito del 2,2%, in controtendenza rispetto a Francia e Germania, dove si sono registrate diminuzioni rispettivamente del 7,7% e dello 0,9%. In termini di valore aggiunto, invece, l’Italia ha conquistato lo scorso anno la leadership europea, superando Spagna e Francia – quest’ultima detentrice del primato nel 2023 – e consolidando così la sua posizione di eccellenza.
CRESCITA E COMPETITIVITÀ
L’ottimo stato di salute del settore agroalimentare è confermato dall’ultimo rapporto ISMEA, l’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare. Nel 2024 è cresciuta non solo l’importanza del settore nell’economia nazionale, ma si è anche consolidata la capacità di esportazione delle produzioni più rappresentative del “Made in Italy”. In dieci anni, le esportazioni agroalimentari italiane sono quasi raddoppiate, superando la cifra record di 69 miliardi di euro: un risultato che testimonia la qualità e la competitività delle nostre produzioni, ovunque riconosciute e apprezzate. Non a caso il nostro Paese è primo al mondo per numero di DOP, IGP e STG, con più di un quinto dei prodotti agroalimentari e quasi un terzo dei vini certificati in UE. Il peso della DOP Economy (20 miliardi di euro e 850mila occupati) rispetto all’agroalimentare nazionale è di circa il 20%, in aumento di tre punti percentuali rispetto a dieci anni fa. Secondo la ricerca “Analisi di scenario e sfide future per il settore agro-alimentare” di Intesa San Paolo, l’export è cresciuto dell’8,3% nel 2024 rispetto all’anno precedente, registrando un’ulteriore crescita nel primo trimestre di quest’anno. In particolare, i prodotti agricoli hanno mostrato un aumento tendenziale del 7,3%, mentre i prodotti alimentari e le bevande sono cresciuti del 4,9%.
Nonostante la potenziale minaccia di dazi aggiuntivi possa avere un impatto rilevante sulle esportazioni, il posizionamento qualitativo dei prodotti italiani può giocare un ruolo cruciale: il 54,1% dell’export alimentare italiano verso gli USA è infatti rappresentato da prodotti di alta gamma. Le imprese stanno reagendo attivamente alle sfide dei dazi; non hanno solo intrapreso strategie mirate a rimanere competitivi sul mercato americano, perché oltre il 60% dei rispondenti ha dichiarato di aver anche iniziato la ricerca di nuovi clienti in altri mercati. Inoltre, la domanda interna di prodotti agroalimentari è prevista in crescita a un ritmo stabile (+0,6% annuo a prezzi costanti) nel biennio 2025-26, sostenuta dal recupero delle spese finali delle famiglie, e dal contributo del canale Horeca, grazie alle previsioni del buon andamento dei flussi turistici, anche in concomitanza con eventi come il Giubileo e le Olimpiadi.
CRITICITÀ STRUTTURALI
Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano, tra il 2010 e il 2020 il numero delle aziende agricole in Italia è diminuito del 30%, con una chiusura particolarmente accentuata tra le realtà di piccole dimensioni. Anche i dati Istat evidenziano una riduzione del 2,6% degli addetti agricoli, trainata da un calo significativo dei lavoratori indipendenti (-4,4%), parzialmente bilanciato solo dal lieve aumento degli occupati dipendenti (+0,9%). Il settore agricolo italiano è in piena trasformazione. Per restare competitivo, gli operatori puntano a ottimizzare i processi produttivi, allargare le aziende, diversificare l’offerta e innalzare la qualità dei prodotti.
I dati dell’Osservatorio evidenziano che, dopo anni di crescita a doppia cifra negli investimenti in tecnologie digitali lungo tutta la filiera, lo scorso anno si è registrata per la prima volta una flessione. Il calo riguarda principalmente gli investimenti in hardware – in particolare macchinari e accessori connessi – mentre gli investimenti in software hanno continuato a crescere in modo costante. Dopo aver rinnovato il parco macchine e avviato la raccolta dei dati, il settore è ora focalizzato sul loro utilizzo strategico per ottimizzare il monitoraggio e la gestione dei processi. Cresce così l’adozione di soluzioni avanzate come i FMIS (Farm Management Information System), i sistemi di monitoraggio e mappatura delle colture e le piattaforme di supporto alle decisioni, che trasformano i dati in leve operative concrete. Nel contesto attuale, segnato da forti perturbazioni, l’Osservatorio evidenzia come le imprese agricole italiane sentano soprattutto l’esigenza di migliorare la capacità previsionale (41%), potenziare le attività di controllo e gestione (38%), ottimizzare la pianificazione operativa (32%) e aumentare la consapevolezza interna sulle dinamiche aziendali (31%).
Tuttavia, la maturità digitale degli operatori resta ancora molto limitata: oltre il 90% delle aziende non ha investito in soluzioni digitali e non è certa di farlo nei prossimi anni. Un fattore chiave che influenza la propensione all’innovazione è la dimensione aziendale, con le realtà più piccole spesso frenate da risorse e capacità limitate. Questo riflette una delle criticità strutturali più rilevanti della filiera agroalimentare italiana: l’eccessivo frazionamento delle imprese. Per evitare che la trasformazione digitale resti appannaggio di una ristretta minoranza, e per garantire un aumento generalizzato della competitività, anche sui mercati internazionali, è fondamentale favorire la crescita dimensionale delle aziende e promuovere forme di aggregazione, come cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori. In questo contesto, un ruolo determinante può essere svolto dalle imprese di trasformazione, che, in qualità di capofila della filiera, possono accompagnare le aziende agricole nell’adozione di tecnologie digitali, valorizzando anche economicamente la qualità delle produzioni. Particolarmente nel settore agricolo, diventa necessario potenziare le conoscenze tecniche relative alle nuove tecnologie digitali e formare nuove figure professionali in grado di comprendere i bisogni, le sfide e gli obiettivi delle aziende, guidandole nel percorso di digitalizzazione e facilitando il dialogo con i provider tecnologici. Solo così si potrà costruire un’agricoltura più moderna, efficiente e competitiva.
TUTELA DEL MARCHIO
Oltre agli investimenti nel digitale, le aziende dell’agroalimentare da tempo hanno iniziato a interessarsi all’intelligenza artificiale e al machine learning, prima con delle sperimentazioni, poi con delle soluzioni anche complesse basate su queste tecnologie. L’intelligenza artificiale viene impiegata per migliorare l’efficienza nelle diverse fasi produttive, ottimizzare l’uso delle risorse, garantire la sicurezza alimentare, supportare l’approvvigionamento delle materie prime, rafforzare la tracciabilità e rendere più efficiente la gestione logistica. Nel settore agricolo, inoltre, l’AI viene sfruttata per la gestione delle attività in campo, l’agricoltura di precisione, la protezione delle colture, la creazione di una agricoltura sempre più sostenibile, il controllo di fattori di produzione come agrofarmaci e acqua.
Le aziende trasformatrici con l’AI monitorano e gestiscono anche la qualità dei prodotti e la loro tracciabilità. Alcune aziende hanno anche creato chatbot per fornire consigli personalizzati sui loro prodotti ai consumatori, basati sulle loro preferenze e sulle loro esigenze nutrizionali. Interessanti anche le soluzioni per il marketing AI-based, che impiega di algoritmi di machine learning per analizzare i dati e aumentare l’efficacia delle strategie di vendita. Si stanno diffondendo anche applicazioni per il settore R&D, per facilitare la progettazione e la formulazione di prodotti alimentari innovativi, attività che necessita di processi complessi con la gestione di numerosi parametri di progettazione: l’AI e le reti neurali possono elaborare grandi volumi di dati per guidare le aziende a trasformare più rapidamente le tendenze di mercato e le esigenze dei consumatori in prodotti gustosi, sani ed apprezzati. Le tecniche di AI si sono anche evolute in strumenti pratici, rapidi ed efficaci utilizzati con dispositivi per la valutazione della qualità, per il rilevamento di adulterazioni e di difetti dei prodotti agricoli e alimentari. Tra le applicazioni più interessanti, vi è la protezione dei marchi di qualità.
Un esempio è il sistema di tracciabilità, unico in Europa, del Consorzio di tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP, in grado di tutelare allevatori e produttori e garantire ai consumatori finali che il latte utilizzato per la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sia 100% latte di bufala intero fresco, proveniente da bufale allevate solo in precise zone, che costituiscono l’area territoriale della DOP. Questo sistema è frutto del lavoro congiunto dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, del Ministero delle Politiche agricole, del Dipartimento Qualità Alimentare Certificazioni e del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana DOP. Tutti gli attori della filiera, che a qualsiasi titolo entrano in contatto con la materia prima, sono obbligati a registrare quanto è stato prodotto, trasferito o trasformato. Il sistema si basa su AI, addestrata attraverso l’esame di tutte le etichette dei soci del consorzio (oltre seimila e settecento etichette singole) per verificare i riferimenti specifici al prodotto, identificando imitazioni e contraffazioni sulle confezioni e distinguendo l’autentico dal falso.
PRODUZIONE INTELLIGENTE
L’intelligenza artificiale, attraverso l’integrazione di reti neurali e sistemi di controllo predittivo, consente di sviluppare un’agricoltura di precisione sempre più avanzata, capace di adattarsi in modo dinamico alle diverse condizioni ambientali e strutturali. Un approccio che trasforma i dati in decisioni operative, aumentando efficienza, produttività e sostenibilità. Questo è reso possibile dall’analisi di migliaia di dati generati dai sensori presenti in azienda: informazioni dettagliate sulla mappatura dei terreni, sul loro stato, sulla presenza di parassiti e malattie, integrate con previsioni meteorologiche e dati storici relativi ai raccolti degli anni precedenti.
I sistemi, potenziati dall’intelligenza artificiale, monitorano in tempo reale parametri chiave come temperatura, umidità, anidride carbonica, irrigazione e fertilizzazione. Grazie all’apprendimento automatico, sono in grado di adattare le decisioni operative anche di fronte a variazioni improvvise delle condizioni meteo, ottimizzando la crescita delle colture, regolando il microclima in ambienti controllati, migliorando la gestione dello stato vegetativo e aumentando l’efficienza energetica complessiva del sistema agricolo.
È il caso della Società Agricola Egiziaca, che in provincia di Napoli coltiva su 300 ettari diversi prodotti orticoli, soprattutto pomodori, insalata, meloni, colture con diverse necessità e diverse problematiche, da gestire su una vasta superficie. Questa la sfida che l’azienda affronta ogni giorno: ogni lotto ha una gestione a sé, ed è importante tracciare cosa succede su ciascun appezzamento, per creare uno storico su cui basarsi quando si prendono decisioni. La mole di dati che si possono ricavare dal campo è immensa, da tutte le informazioni relative alle varie operazioni svolte nei campi a quelle raccolte dai sensori installati, o quelle amministrative: dati relativi ai macchinari, difesa delle colture dai patogeni, dati di irrigazione, persino le ore di lavoro dei dipendenti. Per avere prodotti a residuo zero, vengono usati modelli predittivi dell’andamento delle popolazioni di insetti o delle patologie fungine e batteriche, che elaborando i dati raccolti in campo aiutano a razionalizzare l’uso dei prodotti fitosanitari.
Questi strumenti indicano quando è opportuno evitare i trattamenti – per esempio in assenza di rischio reale di infezioni o attacchi parassitari – e quando, al contrario, è necessario intervenire tempestivamente per prevenire infestazioni più gravi. Ridurre o eliminare gli interventi non strettamente necessari non solo consente alle aziende agricole un significativo risparmio economico, ma rende anche l’intero processo produttivo più sostenibile, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo “residuo zero”. Negli ultimi anni, la crescente scarsità d’acqua legata alla riduzione delle piogge ha reso indispensabile un uso più efficiente delle risorse idriche. Anche in questo ambito, la tecnologia permette di fare la differenza: attraverso sistemi intelligenti, è possibile pianificare strategie irrigue mirate, ricevendo indicazioni precise su quando e quanto irrigare in base alle reali esigenze della coltura, riducendo gli sprechi e tutelando l’ambiente.
TRACCIABILITÀ E SICUREZZA
Per il settore agroalimentare è vitale tenere traccia di un alimento o di un prodotto, poter risalire alla sua storia in ogni fase della supply chain. La tracciabilità è alla base della food safety, garantisce una piena trasparenza, fornendo ai consumatori informazioni chiare e precise sui prodotti in circolazione per poter fare scelte consapevoli, e consente di assicurare la distribuzione di alimenti sicuri e sani e di gestire in modo rapido le eventuali situazioni problematiche. Le filiere agroalimentari stanno diventando sempre più digitali e automatizzate grazie all’impiego di tecnologie come l’IoT, la blockchain e l’intelligenza artificiale.
In particolare, blockchain e AI stanno rivoluzionando la tracciabilità degli alimenti, permettendo la costruzione di un modello informativo più rapido, affidabile e sicuro. Queste tecnologie garantiscono una gestione dei dati più riservata e trasparente, identificano in modo univoco ogni controllo lungo la filiera e assicurano la piena visibilità delle informazioni, dalla produzione alla distribuzione.
È il caso del Pastificio 28 Pastai di Gragnano, che ha implementato un sistema di tracciabilità basato su blockchain lungo l’intera filiera del grano: dai campi di coltivazione, passando per il mulino che trasforma il grano in semola, fino al confezionamento del prodotto finale. Il Pastificio 28 Pastai è il primo in Italia a certificare l’assenza di pesticidi e glifosato nei grani utilizzati. Una scelta che non solo garantisce un prodotto più sano per il consumatore, ma rappresenta anche una conferma indiretta della provenienza 100% italiana della semola impiegata. La produzione si basa su una miscela di cinque varietà di grano duro coltivate nelle Colline Frentane, un’area caratterizzata da un clima fresco e asciutto, ideale per ridurre in modo naturale la presenza di funghi dannosi. La gestione agronomica adotta tecniche a basso impatto ambientale: arature profonde eseguite prima della semina e l’utilizzo di strumenti meccanici come lo “striatore” permettono di eliminare le erbe infestanti senza ricorrere a diserbanti chimici.
L’intera filiera del Pastificio 28 Pastai – dall’origine del grano fino ai tempi e alle temperature di essiccazione della pasta – è tracciata, certificata e consultabile tramite il QR Code presente su ogni confezione. Grazie al collegamento diretto tra la piattaforma blockchain e le celle di essiccazione, è possibile monitorare in tempo reale i consumi energetici e certificare in modo trasparente durata e temperatura del processo: un modo concreto per verificare se la pasta è stata davvero sottoposta alla “lenta essiccazione a basse temperature” spesso evocata nelle comunicazioni di marketing. L’azienda ha inoltre implementato soluzioni per il risparmio idrico nei campi di coltivazione e sistemi di monitoraggio dei consumi energetici sulle linee produttive, parzialmente o totalmente compensati da energia rinnovabile generata da impianti fotovoltaici.
DATI INTEROPERABILI
Nella filiera agroalimentare, la frammentazione tecnologica rappresenta una criticità crescente: molte aziende agricole e alimentari adottano strumenti digitali tra loro incompatibili, con conseguenti difficoltà nell’interoperabilità dei sistemi e nella condivisione efficace dei dati lungo la catena del valore. Negli ultimi anni è stato introdotto un riferimento georeferenziato condiviso per il settore, pensato per abilitare l’interoperabilità tra i diversi strumenti digitali utilizzati lungo l’intera catena del valore. Questo standard comune favorisce la collaborazione tra attori della filiera, semplifica la tracciabilità dei prodotti e rappresenta un passo strategico verso la costruzione di un sistema alimentare più integrato, trasparente e sostenibile. Il Global Field ID (GFID) è un identificativo univoco, assegnato a ogni appezzamento agricolo a livello globale. Attualmente, il sistema conta oltre 200 milioni record, ciascuno associato a un codice esclusivo che ne garantisce la tracciabilità e l’univocità su scala mondiale.
L’obiettivo principale del Global Field ID (GFID) è facilitare l’accesso degli agricoltori alle piattaforme digitali, ridurre i costi legati all’interoperabilità dei sistemi e promuovere la condivisione dei dati agricoli tra aziende agricole e alimentari, istituzioni governative, finanziatori, assicuratori, distributori e consumatori. La tecnologia GFID assegna un confine univoco a ogni appezzamento, minimizzando così il rischio di doppie contabilizzazioni e rendendo il sistema uno strumento efficace per il reporting sulla sostenibilità ambientale.
Proprio per questi vantaggi, Simpsons Malt – storica azienda fondata nel 1862 e fornitore di malto per brand prestigiosi come Chivas e Macallan – ha adottato il GFID per migliorare la tracciabilità delle pratiche agricole e misurare con maggiore precisione la riduzione delle emissioni di carbonio lungo la propria filiera. Integrando il GFID nel sistema digitale, Simpsons Malt è riuscita ad associare i dati agronomici direttamente alle singole parcelle di coltivazione del luppolo, garantendo così una misurazione più accurata delle emissioni e semplificando la rendicontazione ambientale.
LOGISTICA INTEGRATA
I sistemi di intelligenza artificiale stanno rivoluzionando anche la gestione della domanda e l’ottimizzazione delle scorte nel settore agroalimentare, migliorando il monitoraggio dei livelli di magazzino e riducendo sprechi e scarti alimentari. Un caso emblematico è Geldi, storica realtà della provincia di Chieti, attiva da quasi cinquant’anni nella distribuzione di prodotti freschi e surgelati per bar e ristoranti. Partita come impresa locale, Geldi ha ampliato la sua presenza nel Centro Italia e, con il lancio dell’e-commerce Puntoqui.com, ha esteso la propria offerta direttamente ai consumatori, garantendo consegne a domicilio rapide e affidabili. Oggi l’azienda conta oltre 250 dipendenti e agenti, un fatturato di 47 milioni di euro e un servizio di distribuzione attivo 24 ore su 24. La gestione dei magazzini e degli approvvigionamenti è sempre più avanzata: attraverso un sistema di monitoraggio continuo dei lotti e delle scadenze, Geldi evita il deterioramento degli alimenti e minimizza la produzione di rifiuti e scarti. Il cuore dell’efficienza è un sistema predittivo che calibra gli ordini in base alle previsioni di vendita per ogni singola referenza, tenendo conto di variazioni stagionali e picchi di domanda legati a periodi particolari come il Natale. Questo approccio permette all’azienda di evitare accumuli eccessivi di prodotti invenduti, ottimizzando il flusso logistico e riducendo l’impatto ambientale.
EFFICIENZA E QUALITÀ
L’AI ha molte applicazioni anche nell’analisi predittiva e nella manutenzione preventiva delle attrezzature di produzione: in questo modo contribuisce a ridurre i tempi di inattività e a massimizzare l’efficienza operativa. L’introduzione dell’AI nei processi produttivi consente di ridurre le attività manuali, garantendo standard qualitativi elevati. È il caso di Simonelli Group (simonelligroup.com), azienda fondata nel 1936, con sede in Italia, leader nel settore della produzione di macchine da caffè e macinacaffè professionali e domestici distribuiti attraverso due marchi: Nuova Simonelli e Victoria Arduino.
Con circa 160 dipendenti e un fatturato annuo vicino ai 110 milioni di euro, Simonelli Group si colloca tra i primi cinque produttori mondiali nel suo settore, esportando in oltre 110 paesi e collaborando con le principali catene di ristorazione e torrefazioni internazionali. L’azienda ha sviluppato una macchina professionale pensata per grandi catene di ristorazione e coffee shop, che consente di erogare un caffè di alta qualità anche in contesti dove il personale ha scarsa specializzazione nella torrefazione. Grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning, la macchina da caffè e il macinacaffè sono in grado di comunicare tra loro, riconoscendo automaticamente filtri e miscele, e impostando in modo autonomo i parametri di macinatura ed erogazione. Questo riduce drasticamente le operazioni a carico del barista, minimizzando gli sprechi di caffè, energia e acqua. La tecnologia C-Automation, implementata nel nuovo modello “Nuova Aurelia”, consente di erogare una bevanda perfetta senza ulteriori interventi manuali, calibrandosi automaticamente in base alle variazioni delle condizioni ambientali, come umidità, temperatura e composizione della miscela, per garantire sempre un caffè eccellente.
Brother: Data Product Management
Eos Solutions: Industria alimentare 4.0. Sostenibilità e competitività nell’era dell’AI
Formula: L’industria alimentare nell’era della trasformazione digitale
Sinfo One: Marginalità e ESG: come sopravvivere?